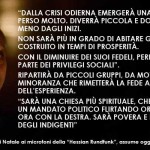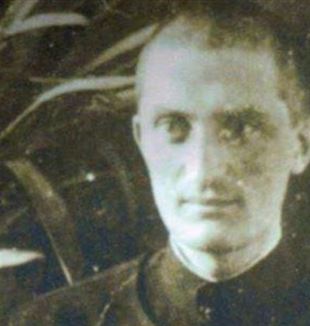DARIO VERMI O.H. Postulatore Generale
FBF_rivista_ottobre_dicembre2023.pdf (hubspotusercontent-na1.net)
A 165 chilometri da Madrid si trova la città di Cuenca, nelle cui vicinanze è situato il villaggio di Cañaveruelas, dove è iniziata l’avventura terrena di Fra Bonifacio. Il piccolo paese prende il nome dall’abbondanza di canneti lungo il fiume Garibay nome di derivazio ne araba che significa “le rocce”. I suoi abitanti hanno sempre coltivato cereali e, oggi, anche girasoli e sono fortemente legati alle usanze e alle tradizioni religiose, così come il culto dei morti. In questo luogo, al numero 4 di via El Mesón, dal matrimonio tra Manuel Bonillo e Higinia Fernández, nacque Bonifacio, all’una di notte del 14 maggio 1899. Fu battezzato tre giorni dopo, come registrato nel libro parrocchiale di Nostra Signora della Pace. Il piccolo fu la gioia dell’umile famiglia, cui era rima sta la sola figlia Juana, perché l’altra figlia Fernanda era morta in tenera età. Anche Bonifacio da bambi no si ammalò e, secondo il suo stesso racconto, la madre lo offrì alla Madonna per farlo guarire. Bonifacio guarito dalla sua malattia crebbe sano, irrequieto e allegro, sempre pronto ad aiutare gli al tri, nonostante la sua condizione familiare fosse indigente; infatti, i genitori possedevano solo una piccola casa dove nacque il Servo di Dio.
Bonifacio guarito dalla sua malattia crebbe sano, irrequieto e allegro, sempre pronto ad aiutare gli al tri, nonostante la sua condizione familiare fosse indigente; infatti, i genitori possedevano solo un piccolo orto, con il quale la famiglia riusciva a stento a vivere, non avendo alcun’altra fonte di reddito. Fece la prima comunione nella solennità del Corpus Domini del 1908. La sua infanzia fu serena, fino alla morte del padre, avvenuta il 7 gennaio 1909. Poiché era l’unico maschio della famiglia, dovette coniugare lo studio con il lavoro, provvedendo alla madre e alla sorella. Allo stesso tempo intratteneva una sana amicizia con i ragazzi del villaggio e, come raccontava Juliana Alcañíz, che “è stata una vicina di casa per tutta la vita”, era sempre disponibile a portare il suo aiuto a chiunque si trovasse nel bisogno. Non si risparmiava neppure nella fucina del cognato, svolgendo il lavoro di fabbro. All’età di 22 anni si innamorò di una bella ragazza del paese, Lorenza, con la quale si fidanzò per due anni, ma a causa delle difficoltà economiche che avrebbero dovuto affrontare in futuro, comprese che la loro relazione era senza prospettive. Rimase nel suo villaggio fino al 1923 e, poiché era figlio di madre vedova, venne esonerato dal servizio militare.
Con alcuni amici del suo villaggio si recava nella vicina città di Arganda del Rey per lavorare presso le vigne durante la vendemmia. Ma anche questi lavori stagionali avevano un termine. Così con Félix, un amico del gruppo, si recò prima a Madrid in cerca di una qualche attività, ma senza successo, e poi a Saragozza dove fu ancora un fallimento. A questo punto più che mai deciso disse all’amico: “Vado a Barcellona per trovare lavoro affidandomi alla fortu na”. Il giovane Bonifacio intraprese questo viaggio da solo, mentre l’amico Félix preferì rimanere con la famiglia nel villaggio natio.
Interno della chiesa di Nostra Signore della Pace. IL CENTRO DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE A Barcellona era in piena attività il Centro dell’Im macolata Concezione dei Fatebenefratelli che era stato fondato il 26 febbraio 1882 e inaugurato nel 1908. All’inizio c’erano solo tre confratelli, sei bam bini malati e un numero molto ridotto di collabo ratori. I bambini accolti, in età compresa tra i 5 e i 16 anni, che arrivarono ad essere 250, presentavano diverse patologie: invalidi, tignosi, ciechi, scrofolosi, e per loro nel 1924 si introdusse la balneoterapia marittima nel Sanatorio di Calafell, un’altra opera gestita dai religiosi dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio.
Il Nostro, mentre si trovava a Barcellona, senza alcuna speranza di lavoro, leggendo il giornale scoprì che i Fratelli di San Giovanni di Dio del Centro dell’Immacolata avevano bisogno di un fattorino; e così Bonifacio recatosi al luogo indicato ottenne l’incarico. I religiosi, che si distinguevano per l’amo re verso i poveri e i bisognosi ed erano sempre at tenti alla vita spirituale dei bambini malati. Entusiasta per ciò che stava vivendo, scrisse alla madre, alla sorella e all’amico Félix raccontan do loro la bella testimonianza di fede dei Fratelli. Dopo qualche mese, comunicò loro che si sentiva chiamato alla vita religiosa secondo lo stile di San Giovanni di Dio, e così chiese di entrare nell’Ordine Ospedaliero. Per questa ragione i religiosi chiesero 7 6 informazioni su Bonifacio gendosi al Comune di Cañaveruelas; nonostante l’opposizione di Jorge Baquero, padre della sua ex fidanzata e sindaco del paese, i consiglieri comunali inviarono un certificato di buona condotta in quanto ritenevano Bonifacio la persona migliore di Cañaveruelas e non volevano essere ingrati nei suoi confronti. Ciò fece sì che i Fra telli lo accettassero nella loro missione.
LA SITUAZIONE IN SPAGNA
Nel 1899 quando nacque Bonifacio, Maria Cristina, seconda moglie del re Alfonso XII, governava la Spagna che aveva perso parte del suo immenso impero: Cuba, Porto Rico, le Filippine. Due grandi forze politiche dominavano la Spagna: i partiti dei con servatori e dei liberali. Si susseguivano crisi di gover no, con continui cambi di ministri e divergenze di opinione tra i partiti stessi. Nonostante le difficoltà si poteva registrare una crescita economica, la dif fusione dell’illuminazione elettrica che aveva sosti tuito il gas nelle città, una rivoluzione nei trasporti, lo sviluppo dell’industria automobilistica, dell’indu stria chimica e degli armamenti, come pure dell’in dustria tessile e dell’agricoltura. In Spagna c’erano circa diciannove milioni di abitanti. Tale fu il clima sociale e civile nel quale visse Bonifacio, che nonostante un’infanzia povera, semplice e manchevole di una formazione scolastica, fu comunque un ragazzo gioioso. Questi cresceva sopperendo alla scarsa istruzione ricevuta con la sua 8 brillante intelligenza e con la sua innata capacità di comprendere e di convincere gli altri. In questo contesto si svolgeva anche la grande opera dei Fratelli di San Giovanni di Dio. Ma chi era questo Santo che aveva tanto colpito il giovane Bonifacio durante il suo soggiorno a Bar cellona?
L’INFLUSSO DI SAN GIOVANNI DI DIO
Giovanni di Dio nacque a Montemor o Novo (Portogallo) nel 1495. Figlio di genitori cristiani, all’età di otto anni partì da casa per Oropesa (Toledo) e vi rimase, per circa vent’anni, con la famiglia di Francisco Gil (Mayoral), come responsabile del gregge e dei campi di D. Francisco Álvarez di Toledo. Dopo qualche tempo, ritenendolo bravo, vollero dargli in sposa la figlia del sindaco, ma lui si arruolò come soldato per combattere contro i francesi; così si recò a Fuenterrabía. Al servizio dell’imperatore Carlo V proseguì fino a Pavia, poi partecipò alla difesa di Vienna contro i Turchi con le armate di Don Giovanni d’Austria. Soddi sfatto del servizio prestato, ma anche stanco, tornò a La Coruña e da lì nella casa paterna in Portogallo, ma si rattristò nell’apprendere che sua madre era già morta e che suo padre era entrato in un convento francescano dove morì santamente. Tornato in Spa gna passando per Siviglia, continuò a fare il pastore, poi si recò a Ceuta, dove lavorò come muratore. 9 Le sue peregrinazioni non erano finite, fece ritor no nuovamente in Spagna, passando per Gibilterra, dove vendeva libri religiosi, profani e romanzi. Era il 1538. Viaggiò in altre città, finché, carico di libri, si recò a Gaucín (Malaga). In questo momento della sua travagliata vita il Santo fece un incontro che fu decisivo per la sua vocazione. La tradizione tramanda che avendo visto un bambino malvestito e scalzo lo caricò sulle spal le. Giunto nei pressi di una fontana prese dell’acqua per il piccolo assetato e voltatosi indietro lo trovò raggiante con una melagrana in mano che gli dice va: “Giovanni di Dio, Granada sarà la tua croce”.
Era il Bambino Gesù e in quell’attimo scomparve dalla sua vista. Di fatto da quell’istante gli fu chiara la destina zione del suo viaggio: Granada. Quando arrivò in città, all’ingresso, in via Elvira, vicino all’omonima porta, iniziò a vendere libri. Il 20 gennaio 1539, Giovanni d’Avila predicò nell’eremo dei Martiri e Giovanni di Dio andò ad ascoltarlo. Sentendolo, rimase sconvolto e termi nata la predica uscì di là come fuori di sé, chie dendo ad alta voce pietà e misericordia a Dio e implorando perdono per i suoi peccati. Tornato al negozio, regalò i libri religiosi, distrusse quelli pro fani e distribuì il denaro guadagnato a coloro che passavano. Preso per pazzo, fu internato all’Ospedale Reale, dove fu maltrattato, come era consuetudine all’e poca, e dove lui stesso si prese cura degli altri rico 10 verati. È qui che si forgiò l’avventura della sua vita e che gli ispirò: “Se solo potessi avere un giorno un ospedale dove poter curare questi malati come meri tano!”. Dopo qualche tempo, dimesso dall’ospedale, partì e si recò a Baeza, dove Giovanni d’Avila gli diede dei consigli e poi proseguì in pellegrinaggio al Monastero di Guadalupe. Da allora la Vergine Maria sarebbe stata la sua protettrice e in quel luogo san to avrebbe trovato aiuto e formazione negli studi “infermieristici”, per realizzare la sua futura missione. Tornò a Granada, sentendosi pronto ad aiutare i poveri e i malati che incontrava per strada, assisten doli durante il giorno e uscendo anche di notte per chiedere l’elemosina al grido: “Fratelli, fate del bene a voi stessi facendo l’elemosina ai poveri”.
Il Santo iniziò da solo il servizio nel suo ospedale. Il sacerdote Francisco de Castro, suo primo e miglior biografo, scrive: “Dopo aver mangiato e pregato per i benefattori, egli si dedicava a lavare i piatti e le scodelle, lavare le pentole, spazzare e pulire la casa, e a prendere l’acqua con due brocche dalla colonna, con grande fatica, perché, essendosi appena ricordato di essere stato pazzo, e avendolo visto così maltrattato, non voleva che qualcuno venisse in sua compagnia ad aiutarlo; e così portava avanti il lavoro da solo, finché non vennero a sapere chi fosse.”.
In seguito, alcuni convalescenti lo aiutarono in questi compiti, finché i primi discepoli si unirono a lui. Chiedeva l’elemosina nel silenzio della notte. Prendeva due brocche, legate con uno spago, le appendeva a un braccio, mentre sulle spalle portava un grande cesto, e in questo modo camminava per le strade di Granada portando spesso sulle spalle dei poveri infermi che raccoglieva per strada. Al seguito del Maestro d’Avila, Giovanni di Dio camminava per Cordova, come egli stesso ci racconta: “quando mi trovavo a Cordova, camminando per la città, trovai alcuni poveri che erano così mal curati che mi si spezzò il cuore e li aiutai come meglio potevo”. Viveva donando tutto se stesso portando sollievo ai malati, assistendo i poveri e prendendosi cura dei più bisognosi. A Granada, nel luglio del 1549, scoppiò un incendio nell’Ospedale Reale, al grido dei poveri infermi, egli si gettò nelle fiamme per sal varli tutti. Chi lo vedeva non ricordava più il pazzo, ma lo acclamava come un santo. Un giorno mentre cercava di salvare un ragazzo che stava annegando nel fiume Genil, contrasse una polmonite e fu co stretto a letto. Giovanni di Dio a malincuore accettò di essere portato nella dimora della nobile famiglia dei “Los Pisa”, a lui molto affezionata, e vi rimase die ci giorni. Il giorno della morte fu trovato in ginoc chio nella sua stanza, abbracciato al crocifisso e con lo sguardo rivolto al cielo. I presenti pensarono che fosse in preghiera, ma la sua anima innamorata di Dio era già in viaggio verso il Padre. L’8 marzo 1550 sarà per sempre ricordato come il giorno in cui la misericordia è entrata in cielo vestita da Giovanni di Dio. Non era strano. Era così che ave va vissuto: prostrato e tenendo tra le braccia i “Cristi viventi” che aveva incontrato durante la sua vita. Per la sua fama di santità, ancora oggi molti seguono il suo percorso di ospitalità in tutto il mondo. 12 Fra Bonifacio Bonillo.
INGRESSO NELL’ORDINE OSPEDALIERO
Bonifacio arrivato il 12 agosto 1924 alla stazione di Ciempozuelos, si incamminò verso il Sana torio Psichiatrico di San José, gestito dai Fratelli di San Giovanni di Dio, dove sarebbe iniziata l’avventura della sua vita. E qui cominciò la sua fase formativa. Nella preghiera trovò la forza di non arrendersi e di non guardare a ciò che aveva la sciato: madre, sorella, fidanzata, amici, città, ma confortato dall’Eucaristia quotidiana, dalla recita del rosario, dalla meditazione della Parola di Dio, dalla devozione mariana e da un’adeguata vita sacramentale, fece a poco a poco passi decisi, aiutato dal clima di vicinanza e di fiducia che trovò tra i suoi compagni e nei religiosi. L’assistenza ai malati, ai quali dedicò i suoi servizi, divenne fin dal primo momento il suo carisma. Parte del suo tempo era dedicato anche alla formazione con apposite lezioni di cultura generale e con studi dei fondamenti dell’Ordine Ospedaliero. La carità è la forma concreta di ospitalità per alleviare le sofferenze di tanti malati, poveri e bisogno si. E in questo i formandi avevano come specchio il santo fondatore dell’Ordine Ospedaliero, alla sua sequela sempre più la loro vita poteva identificarsi con Cristo.
Al termine del postulantato, l’8 dicembre 1924, si trasferì nel noviziato del Centro San José de Carabanchel Alto vicino a Madrid. Indossato l’abito 14 ospedaliero, la comunità accolse con gioia i nuovi confratelli, abbracciandoli fraternamente. Fra Bonifacio iniziò il suo noviziato con grande entusiasmo e buona volontà di realizzare la propria vocazione: re quisiti essenziali per consacrarsi a Dio. Le prove che avrebbe dovuto affrontare d’ora in poi non avrebbero avuto importanza. La conoscenza della Regola e delle Costituzioni, la progressiva maturazione dei suoi ideali, la purificazione delle sue motivazioni, un’attenta pratica dell’ospitalità e la formazione a una scelta libera e responsabile facilitarono molto il discernimento della sua vocazione e lo aiutarono a prepararsi, a offrirsi al Signore e alla Chiesa attraverso la profes sione religiosa. Fondazione San José di Carabanchel Alto (Madrid), dove Fra Bonifacio iniziò il noviziato nel 1924. 15 Durante il noviziato visse lo spirito di sacrificio e di penitenza con zelo e adesione spirituale. Ai novizi veniva ricordato quello che San Giovanni di Dio di ceva a questo proposito: “Non c’è contemplazione più alta che quella di contemplare la passione di Cristo” e che “non trovo miglior rimedio e incoraggiamento che guardare Gesù crocifisso”. Da questa scuola tras se gli insegnamenti per alimentare e consolidare la spiritualità ospedaliera affinando la sua sensibilità misericordiosa verso i malati, i poveri ed i bambini che amava con amore di padre. Lo accompagnava la devozione mariana, propo sta nell’imitazione delle virtù della Vergine, che fin dalla tenera età la madre gli aveva insegnato, e lo confortava la recita quotidiana del rosario sempre a imitazione di San Giovanni di Dio, di cui si legge in una delle sue lettere: “Vi dico che mi sono trovato molto bene con la recita del rosario, spero in Dio che lo reciterò finché potrò e Dio lo vorrà”. Fra Bonifacio imparò a esercitarsi nelle virtù proprie dei voti re ligiosi che stava per professare. Per tal fine il motto della sua vita fu sempre: “imparare a vivere in modo semplice, povero e laborioso”. “Sono vestito come si deve, perché sono un povero mendicante”, dirà in seguito alla gente di Cordova che gli chiedeva perché non cambiava il suo vec chio abito e le sue scarpe logore. Il voto di ospita lità, caratteristica specifica dei Fatebenefratelli, era particolarmente praticato in noviziato per addestra re i candidati alla futura missione che li attendeva. Fra Bonifacio imparava ciò che disse San Giovanni di Dio: “La carità è la madre di tutte le virtù”, e come 16 esortava coloro che la praticavano, perché “dove non c’è carità non c’è Dio, anche se Dio è ovunque”. Il Ser vo di Dio sperimentava l’abnegazione e il sacrificio che esigeva l’ospitalità, apprendendo quanto aveva richiesto Giovanni di Dio a un giovane che voleva imitarlo e seguirlo: “Se sapessi con certezza che qui trarreste vantaggio per la vostra anima e per quella di tutti, vi ordinerei subito di venire, ma ho paura che succeda il contrario; mi parrebbe meglio perciò che trascorriate qualche giorno in mezzo ai guai, fino a che siate molto ben assuefatto alle fatiche e all’alternarsi di giornate as sai nere o molto buone; e d’altro canto mi pare che se doveste finire col perdervi, sarebbe molto meglio tornarvene, comunque di tutto questo Dio sa quale è il meglio per voi” . “…mi sembra che procediate come una pietra vagante e come una nave senza remo; perciò, sarà bene che andiate a macerare le vostre carni e a soffrire vita dura per amore di Dio, rendendogli grazie per il bene e per il male”. “Ricordate nostro Signore Gesù Cristo e la sua bene detta Passione, che ha restituito il bene per il male che gli era stato fatto. Così dovete fare anche voi quando venite nella casa di Dio”. “Se venite qui, dovrete soffrire molto, tutto per amo re di Dio, e dovrete obbedire molto e lavorare molto più duramente di quanto abbiate lavorato, e perdere il sonno per curare i poveri e i malati, e tutto per amore di Dio”
“Pensate che sia giunto il momento di scegliere una strada. Se dovete venire qui, fate quello che vi sembra meglio. Ma ricordate che se venite, dovete venire per offrire qualche frutto a Dio, lavorando davvero, non per poltrire, perché al figlio più amato vengono date fatiche maggiori”. “Ora, fate quello che vi sembra meglio, perché non so se il Signore sarà contento di farvi venire in questa casa appena lo desideriamo, o se vuole che soffriate lì. Fate ciò che Dio vi ispira e vedete quale sarà il servizio migliore”. “Per questo non ho altro da dirvi, se non che Dio vi salverà e vi custodirà e vi indirizzerà al suo servizio, così come tutti gli uomini. Non smetto di pregare per voi e per tutti”. “Come ultima osservazione vi dico: vivete con Dio, ascoltate sempre la Messa, confessatevi spesso, se possibile, e non dormite nessuna notte in peccato mortale”. “Amate il Signore nostro Gesù Cristo al di sopra di ogni cosa al mondo, perché quanto più lo amate, tan to più Egli vi ama. Rimanete con Dio e andate con lui”. Incoraggiato da questi desideri, Fra Bonifacio si sentì rassicurato, confortato, e fissò gli occhi e il cuore solo su Dio: “Voglio solo trovare e seguire la volontà di Dio”.
PROFESSIONE DEI VOTI
Al termine del noviziato, il 3 giugno 1926, il Servo di Dio emise la professione dei voti temporanei nella chiesa dell’ospedale psichiatrico San José de Carabanchel Alto. I suoi parenti assistettero alla cerimonia, così come una rappresentanza degli oltre cento bambini e ragazzi affetti da epilessia assistiti nel Centro. Durante la celebrazione eucaristica egli emise i voti temporanei di povertà, castità, obbedienza e ospitalità, e promise di osservare la Regola e le Costituzioni dell’Ordine Ospedaliero. Durante i tre anni di professione semplice, si mise a disposizione dei superiori svolgendo con diligenza e passione i compiti a lui affidati. Tornò a Ciempozuelos, dove per sei mesi lavorò con i confratelli direttamente con i malati di mente. Grazie al suo carattere e alla sua dote di sapersi porre in relazione con gli altri, ed in seguito all’impel lente necessità di beni materiali per i Centri dell’Or Comunità di Ciempozuelos 1925. 19 dine, fu dispensato dalle fasi successive della forma zione e fu incaricato di lavorare come questuante presso il Centro San Giovanni di Dio di Santurce (Bil bao) dal 20 dicembre 1926 fino al 15 ottobre 1927, anno in cui fece ritorno a Madrid. Nella capitale spagnola continuò nel suo compito di elemosiniere f ino al 1931 presso il Centro San Rafael per bambini affetti da poliomielite e tubercolosi ossea.
L’OSPEDALE SAN RAFAEL A MADRID
L’attività ospedaliera dei religiosi al San Rafael iniziò nel 1892 a Pinto (Madrid), trasferitasi poi nel 1900 a Paseo de las Acacias, 6; e infine nel 1912, nel magnifico ospedale di San Rafael nella parte alta dell’Hipódromo (Chamartín), dove si trova oggi. Facendo seguito al desiderio dei Fratelli di vedere migliorata la loro opera caritativa e sociale, il Centro fu ampliato nel 1929 con un altro nuovo padiglione, con una capacità di accogliere oltre trecento bambi ni, per il cui mantenimento si “contava sulla preziosa collaborazione degli instancabili religiosi questuanti”. Il Centro fu inaugurato da re Alfonso XIII, accompa gnato dalla regina Vittoria. Il 3 giugno di quello stesso anno Fra Bonifacio emise la professione solenne nella chiesa del Cen tro San José de Carabanchel Alto, a lui già ben nota, consacrandosi definitivamente a Dio per il servizio dei poveri e malati. Fra Bonifacio chiedeva l’elemosina per le strade di Madrid già da due anni: “Si arrivava a mezzogiorno 20 in strada Los Tres Peces (nel quartiere Lavapiés), pren devamo il tram dall’Hipódromo, per una moneta, e andavamo da La Bombilla”. In seguito, quando gli fu chiesto di parlare della sua salute nel 1973, così dis se: “Avevo male all’udito, alla vista e ai piedi, ma presto recuperai tutti e tre. Il periodo peggiore per i miei piedi fu quando mendicavo a Madrid. Bisognava salire mol te scale, perché non c’erano ancora gli ascensori”. Quando era ancora a Madrid, nel 1931, erano di vampati una serie di incendi in chiese e case religio se, e colonne di fumo si vedevano dai tetti del Centro San José. In quell’occasione, trenta soldati del reggi mento di cavalleria, al comando di un tenente, arriva rono di notte per difendere le strutture da eventuali tentativi di assalto o di incendio doloso. I Fratelli que stuanti, tra cui Fra Bonifacio, pur vestendo i panni di laici, andavano ogni giorno a raccogliere le sottoscri zioni manifestando grande coraggio e uno spirito di Professione solenne, 3 giugno 1929 nella chiesa della Fondazione San José di Carabanchel Alto. 21 sacrificio che li esaltava, e per questo venivano accolti da quasi tutti i benefattori con vera ammirazione e ri spetto vedendo la loro carità disinteressata ed eroica, nonostante le gravi difficoltà e le gravi minacce. La storia successiva è così descritta dal dottor Al varez Sierra: “Poi vennero gli anni della Repubblica, la guerra di liberazione. Durante la guerra civile spagno la i religiosi del Centro furono perseguitati e furono loro ridotte le attività. Tra i frati martirizzati c’era fra Eutimio Aramendía, che era il capo infermiere di que sta Casa. L’edificio fu utilizzato come prigione femminile e successivamente come ospedale militare”.
A GRANADA DA SAN GIOVANNI DI DIO
Dal 1931 al 1934 soggiornò prima a Barcellona, poi a Ciempozuelos, Santurce e Madrid, ed in ogni centro lasciò un buon ricordo di sé. In seguito, Fra Bonifacio fu trasferito a Granada, dove lavorò anche come economo del Centro San Rafael. Fu un periodo intenso dedicato al duro lavoro, perché l’ospedale e la missione di strada lo tenevano molto occupato. Da questa esperienza maturò la convinzione che tutta la sua vita sarebbe stata consacrata nell’ospita lità, ben consapevole che nell’opera di Dio non si falli sce mai. Concentrò tutti i suoi sforzi nel lavorare sodo, nella ricerca del regno di Dio tra i malati e i bambini poveri, e continuando a identificarsi con Gesù attra verso la preghiera, la vita fraterna e il suo apostolato di elemosiniere, come un vero povero di Dio.
CORDOVA UNA CLINICA ACCOGLIENTE
Nel novembre 1934, i Fatebenefratelli, avendo trovato un terreno ideale per il futuro dell’ospitalità infantile, riuscirono faticosamente ad acquistarlo e il 2 gennaio 1935, alla presenza di Adrián Touceda, primo Superiore della Casa, e dei confratelli Crescencio Olivares, Juan Grande, Federico Argüello e Juan Bautista Velázquez, firmarono gli atti per la vendita della proprietà chiamata “Huerta de San Pablo”, realizzando così il progetto della nuova costruzione. Crearono l’Asociación Unión de Damas Pro-Hgary Clínica San Rafael per la fondazione e il sostegno caritatevole per la cura dei bambini poveri e Clinica San Rafael, Cordova. 23 disabili. Nonostante le difficoltà iniziali per pagare gli operai, riuscirono a realizzare l’opera. I lavori pro cedettero bene e i bambini trovarono un luogo ac cogliente e adatto per le loro necessità. La nascente comunità arrivò a Cordova il 12 agosto 1935, e Fra Bonifacio Bonillo iniziò subito la sua opera di que stuante per i bambini. Fra Bonifacio nel 1935. QUESTUANTE A CORDOVA Il 20 ottobre 1935 fu inaugurato ufficialmente la Clinica San Rafael, importante opera per l’Ordine e anche per la città Cordova, alla presenza del Vicario Provinciale, Fra Guillermo Llop, il futuro Beato Marti re, che apprezzò molto gli sforzi fatti per la realizza zione dell’ospedale. Fra Bonifacio passava di porta in porta domandando elemosine, otteneva sottoscrizioni, e bussando alle porte delle aziende e dei negozi chiede va senza esitazione, perché il bisogno era grande. E poiché tutto era insufficiente, iniziò a recarsi nei villaggi e nelle fattorie della provincia, pronunciando sempre la stessa espressione: “C’è qualcosa per i miei poveri figli?”. Il compito sembrava facile, ma quando ogni sera rientrava a casa lo coglieva lo sconforto di non aver appagato le esigenze di tanti bambini. Per questo decise di visitare altre terre in diverse province come mendicante, e così tese la mano verso i benefattori viaggiando per Jaén, Granada, Ciudad Real, Clinica San Rafael in Cordova nel 1948, al tempo di Fra Bonifacio.
Non sempre era soddisfatto, per ché dopo la guerra civile spagnola erano molte le difficoltà: scarsi raccolti e povertà, razionamento del cibo e salari bassi. Pian piano il Servo di Dio conquistava la simpatia di molte persone che riconoscevano la sua dedizione agli altri. Al momento del raccolto, visitava tutte le fattorie e raccoglieva: grano, ceci, olio, olive, uva, vino, mandorle, tacchini, galli, tutto tornava utile. Vedendo la bontà d’animo del religioso, gli dicevano: “se riesci a catturare quell’animale, puoi portarlo con te”. E lui lo rincorreva, con il suo abito, senza risparmiarsi finché non lo prendeva. Comunità di Cordova 1948. È CONOSCIUTO COME “FRA GARBANZO” (FRA CECE) I religiosi moltiplicano gli sforzi. Sempre più bambini vengono trattati per le deformità congenite, per il morbo di Pott, per la tubercolosi ossea e per tutti i tipi di chirurgia ortopedica e generale. Una volta, mentre raccoglieva l’elemosina in una fattoria, il proprietario gli diede una grossa pecora e un sacco di ceci. C’era anche una suora che aveva ricevuto la stessa carità dal proprietario. Mentre sta vano per andarsene, alcuni uomini armati si avvicinarono a lui:– Che bello, abbiamo qui un frate e una suora.– È vero, questo merita di essere festeggiato con un buon pasto!– E un terzo disse: “Che bella idea hai avuto!” Così catturarono i due religiosi e il proprietario della fattoria, macellarono l’animale e mangiarono a sazietà. Dopo essersi stuzzicati e divertiti, si dissero: “Perché non ci divertiamo un po’ con questi due santi?” Presero due asini e misero Fra Bonifacio su uno e la suora sull’altro. Legati piedi e mani, li misero in groppa agli asini. E così, in una posizione ridicola, li fecero girare in continuazione, prendendoli in giro volgarmente. Durante questo malsano gioco, Fra Bonifacio riconobbe uno dei tre personaggi: era il padre di un bambino che era stato operato per una certa malattia alla Clinica qualche tempo prima. Così r volgendosi a lui, disse: “Se questo mi fosse stato fatto quando c’era tuo figlio, sarebbe morto di fame: le pecore che hai appena mangiato e i ceci non li hai presi a me, ma ai poveri bambini malati che sono nella Clinica”. Al sentire questo finalmente l’uomo rientrò in sé, fece cessare le beffe e disse agli altri: “Date il sacco di ceci a “Fra Garbanzo”. Così, da quel momento in poi, cominciarono a chiamarlo con quel nome, senza che questo gli creas se imbarazzo. Se doveva ringraziare per un’elemosi na, scrivere o inviare un saluto si firmava Fra Garban zo. Anche quando in seguito ricevette la decorazione del governo spagnolo e il titolo di Excelentísimo Sr., disse: “Sarò sempre Fra Garbanzo fino alla morte”. Fra Bonifacio dopo la questua quotidiana. L’ARTE DI ESSERE ELEMOSINIERE La semplicità, l’umiltà, la prudenza, l’amore per il la voro e la dedizione al prossimo furono sempre il suo tratto distintivo. Il suo aspetto bonario, la sua simpatia, la sua capacità di convincere gli altri, la sua astuzia e la sua fede in Dio fecero di lui un elemosiniere capace di non tornare mai a mani vuote alla Clinica. Per la sua raccolta aveva preso l’abitudine a fre quentare i locali del centro cittadino e lì incontrava anche coloro che andavano all’elegante e maestoso Savarín, all’Avorio o al Mercantil. Fra Bonifacio si se deva a mezzogiorno, tenendo gli occhi ben aperti e non mangiando nulla, aspettando l’occasione per incontrare i signori e i contadini che potevano aiuta re i suoi bambini. A volte, questi, gli sfuggivano, ma sapeva dove andare a cercarli. E trovati gli elargiva no doni generosi ed in seguito li raggiungeva nelle loro fattorie o nei loro magazzini per raccogliere ciò che era utile per i tanti bambini malati. Conosceva bene il suo campo di lavoro per le elemosine. Sapeva tutto dei benefattori. Se qualcuno vendeva una fattoria o comprava qualcosa di impor tante, sapeva come dirgli: “Che bella vendita hai fatto, perché non mi dai qualcosa per i miei figli?” Allo stesso modo, se avevano avuto un buon raccolto. Andava a trovare i toreri dopo le corride. Se c’era qualche for tunato con la lotteria o altri tipi di gioco, non perde va l’occasione per incontrarli e per congratularsi con Il Servo di Dio in attesa di incontrare i suoi benefattori. 30 loro e poi chiedeva una parte per i suoi bambini. Per questo aveva una buona conoscenza degli ambienti in cui si muoveva e del territorio circostante. Frequentava tutte le battute di caccia sapendo ottenere parte della cacciagione e alleggerire i por tafogli dei cacciatori. Accettava ogni tipo di elemo sina, anche la più improbabile, che poi vendeva o scambiava. Non mostrava mai stanchezza o svogliatezza. Si armava di santa pazienza, imparando l’arte di aspet tare che “il frutto maturi”. Quando lo invitavano a non affaticarsi troppo ri spondeva: “Sono un povero mendicante, faccio quello che devo fare, altri stanno peggio di me”. I Fratelli della sua comunità lo ammiravano; Fra Federico Argüello diceva: “Sono sicuro che passava tutta la notte a pensare come ottenere elemosine migliori, perché nessuno poteva resistergli”. Utilizzava una vecchia Land Rover per raggiungere le campagne cordovane e per caricare tutto quello che gli davano, perché non poteva andarsene a mani vuote. Per molte ragioni, era chiaro che Fra Bonifacio era un buon mendicante al servizio dei bisognosi. È stato un grande samaritano del XX secolo perché la sua coscienza si era formata così da rendere la sua persona tutta solidale con i bisognosi che incontrava lungo la strada. Ed in linea con il Vangelo della misericordia seppe risvegliare i cuori duri e distanti, rendendoli grandi nel servizio agli altri attraverso la sua totale dedizione a Dio.
NON AVEVA BARRIERE NEL “CHIEDERE PER AMORE DI DIO”
Era conosciuto in ogni luogo della provincia di Cordova, poiché le sue visite a questi villaggi erano frequenti, soprattutto durante la stagione della rac colta dei vari prodotti della campagna. Inutile dire che Fra Bonifacio incontrava anche persone rilut tanti e indifferenti. Ma la sua arguzia, la sua bontà riuscivano a vincere sulle resistenze. Una volta, in una strada del Centro di Cordova, fermò un uomo a bordo di un’auto nuova di zecca e gli chiese l’elemosina, ma questi replicò non molto garbatamente di non avere offerte. Il religioso dopo averci pensato un po’ gli disse: “Non sai che la tua auto sembra un’oliva? L’uomo attonito rispose: “Vi dico che non lo so, perché il colore non è lo stesso dell’oliva”. Il religioso a lui: “Beh, l’oliva ha dentro un nocciolo duro, così è l’autista dell’auto” . Il signore scoppiò in una fragorosa risata e alla fine gli elargì una buona offerta. Per attenuare il calore dell’estate cordovana si rese necessario posizionare una struttura metallica sulla terrazza-solarium dei bambini e acquistare una tenda da sole. Fra Bonifacio commentava con i con fratelli della Comunità: “Quando potremo comprare una tenda per la terrazza?”. Per l’acquisto erano necessarie 80.000 pesetas, e per i religiosi era impossibile affrontare una tal spesa. Ma si sa: a Dio tutto è possibile. La Divina Provvidenza non avrebbe fallito. Ecco che l’evento di una corrida fu decisivo. Infatti, l’impresario dell’arena soddisfatto dei pro venti raggiunti donò una buona parte del ricavato al governatore civile a favore delle organizzazioni caritatevoli; si accordarono per devolvere parte del premio alla clinica, che lo destinò all’acquisto della tenda, mentre Fra Bonifacio si impegnò e ottenne l’altra metà del denaro mancante. Così facendo si riuscì a portare a termine il lavoro e a posizionare la tenda con grande gioia e festa per tutti i bam bini. Terrazzo della Clinica San Rafel, Cordova. 33 Così, forti della costanza e del sacrificio di Fra Bonifacio, i confratelli cercarono di migliorarsi ogni giorno e l’ospedale pediatrico continuò a svolgere la sua nobile missione di assistenza e cura dei bam bini malati. Al giubileo d’argento del Centro partecipò tutta la città e riconobbe il bene fatto dai Fratelli di San Giovanni di Dio per il loro lavoro con i bambini. La carità cordovana, promossa dai Fatebenefratelli, unita alla fervente preghiera al servizio dei bam bini con limitazioni fisiche e alla testimonianza del loro spirito di ospitalità venne riconosciuta da tutta l’opinione pubblica e dai media. In quell’occasione fu messa in risalto la figura di Fra Bonifacio e della sua opera di elemosina, per il suo instancabile e am mirevole lavoro. Tra aranci e ulivi la carità cresceva sulle montagne di El Brillante. Fra Bonifacio elargiva sorrisi ed affetto paterno ai suoi bambini. Tutti i malati venivano trattati con massimo af fetto, ma più di una volta, quando il malato era un bambino – nel frattempo l’ospedale aveva già ini ziato a ricoverare pazienti adulti – Fra Bonifacio in vitava i suoi compagni con queste parole: “Trattate molto bene il bambino X, perché è povero”. Era felice nel vederli sorridenti, rilassati e divertiti.
ASTA DI BENEFICENZA
Ogni Natale alla radio durante “l’asta di beneficenza” la sua voce risuonava in tutte le case di Cordova. Questo accadeva perché Fra Bonifacio era considera to come uno di famiglia e tutti si sentivano più vicini ai bambini della clinica. L’emittente locale “Radio Cordova” si offriva di colla borare con il suo staff avvisando il pubblico che Fra Bo nifacio avrebbe visitato negozi e aziende. Anche duran te le vacanze di Natale Fra Bonifacio rimaneva alla radio, perché i bambini volevano parlare con lui al telefono. L’asta divenne popolare poiché Fra Bonifacio aveva una predilezione per alcuni animali (pecore, maiali, tacchini, cani, piccioni, pernici e anche alcuni asini), e anno dopo anno era la gente stessa che portava al Servo di Dio quanto aveva bisogno senza che lui chiedesse. Durante la trasmissione radiofonica si invitava Fra Bonifacio ad intonare un canto, a recitare una poesia composta da lui stesso, improvvisando rime divertenti e spiritose, che erano poi oggetto di offerte e davano risultati. I programmi si inoltravano fino a notte fonda e all’annuncio che Fra Bonifacio avrebbe cantato, le telefonate aumentavano, la gente si commuoveva per l’emozione, ognuno contribuiva come poteva. Era tutto molto semplice. Fra Bonifacio sapeva tutto de gli abitanti di Cordova, grazie alla sua memoria prodigiosa e ai continui contatti che manteneva con loro. Per il Servo di Dio questo era anche il suo campo di apostolato e la sua missione. Organizzò tre festival di corride per raccogliere fondi e diverse feste popolari, sempre a beneficio dei bambini ricoverati perché tutto gli sembrava troppo poco. 35 LA POPOLARITÀ DI FRA BONIFACIO Poche persone a Cordova erano cosi note come lui. Era di statura normale, tarchiato, di corporatura robusta. Si presentava con il suo famoso saturno (cappello dei religiosi), le sue vecchie scarpe “con sumate”, la valigetta portafoglio in mano, la sua enorme simpatia e un ampio sorriso che illuminava il suo volto bonario. Ma si riconosceva anche per la sua grande fede in Dio, il suo discorso sempre evan gelico, la sua costante preghiera, e una grande so miglianza al papa “regnante”, per cui lo chiamavano un “altro Giovanni XXIII”. Era già più che conosciuto e riconosciuto nei Circoli Mercantili o Labrador, nei bar di Savarín, Dunia o Toledo, perché in tutti questi luoghi chiedeva l’elemosina. È vero che più di uno non ricambiava con alcu na elemosina, ma molti altri, guidati dalla bontà del loro cuore, gli mettevano in mano il loro portafoglio affinché potesse prendere la quantità di denaro che riteneva opportuna, sapendo che tratteneva solo il necessario e che ogni spicciolo andava a finire in elemosina. E poiché chiedeva a chi avesse e dava a chi aveva bisogno, era ammirato da tutti.
Se Fra Bonifacio usava la simpatia come stratagemma per ottenere qualcosa, era sempre perché desiderava che il benefattore donasse con gioia e fosse felice di sapere che la sua elemosina andava a buon fine. Lo chiedeva con grazia e con dolcezza. Se andava a incontrare i cacciatori nel luogo dove si raccoglieva la selvaggina uccisa, attendeva seduto ad aspettare 36 sulla porta; se di notte gli veniva detto che molte per sone avrebbero assistito a uno spettacolo teatrale o musicale, senza invito si presentava e si faceva trova re lì senza disturbare. E “qualcosa riceveva sempre”. In effetti, erano in molti ad avergli fatto delle “soffiate” su dove poteva andare, perché c’era sempre “un posto dove raschiare”. Sapeva come chiedere, perché era convinto che chiedere significava dare. “Fate del bene a voi stessi dando ai poveri per amore di Dio”. Quando Fra Bonifacio seppe che il famoso torero di Palma del Río, Manuel Benítez Pérez detto “El Cor dobés”, dava una festa per celebrare i suoi bei tempi, vi si recò e felice di vederlo comparire, prese la sua borsa Fra Bonifacio con il famoso Torero “El Cordobés”. 37 portafoglio, che portava sottobraccio, la alzò per brindare e salutandoli a gran voce disse: “Paesani del Cordobés, Manolete e del Guerra, vediamo se siete generosi e mi lasciate una buona offerta”. Gli applausi furono fragorosi e alla fine del “paseíllo” raccolse abbastanza denaro da sentirsi felice di tornare alla clinica. Juan Muñoz Cascos, autore del libro biografico “El Hermano Bonifacio, Excelentísimo Sr. Limosnero”, scritto con grande affetto per il nostro Servo di Dio, nel capitolo XXIV racconta di aver indagato sulla persona di Fra Bonifacio rivolgendo una domanda precisa a diverse persone di livello sociale differen te: “Qual è la sua opinione su Fra Bonifacio? La riposta fu unanime: “Era un santo; non chiedeva mai nulla per sé stesso, ma tutto per i suoi bambini; non si lamentava mai di nulla; sarebbe difficile per l’Ordine Ospedaliero avere di nuovo un altro frate questuante come lui; sapeva a chi doveva chiedere e come farlo”. E la risposta di Juan Jurado Ruiz, un sacerdote virtuoso che conosceva il servo di Dio fin dal suo Ospedale San Giovanni di Dio di Cordova. arrivo a Cordova, fu chiara e decisa: “In Fra Bonifacio spiccano: l’amore e la dedizione senza limiti per i bi sognosi, fino a dimenticare se stesso per donarsi agli altri; un’umiltà commovente, che non dava mai im portanza all’enorme merito che aveva il suo lavoro di elemosiniere e il suo spirito profondamente religioso, proclamato in molte occasioni durante la sua lunga vita come Fratello di San Giovanni di Dio”. LA CROCE DI BENEMERENZA Poco incline alle celebrazioni e alle decorazioni, nella sua vita quotidiana il Servo di Dio trovava vera gioia nello stare vicino ai benefattori e ai collabora tori. Era felice e a suo agio anche con la gente sem plice della campagna. Conoscendo ogni angolo di tutti i villaggi e le fattorie di Cordova, poteva svolge re meglio il suo lavoro di questuante. Non si limitava a chiedere l’elemosina; quando sapeva che un bambino era malato, lo visitava, gli dimostrava affetto e faceva quello che poteva per la famiglia, in modo da farlo ricoverare nella Clinica San Rafael, motivo per cui era ammirato e rispetta to da tutti. In questo modo realizzava il suo motto: essere semplice, povero e lavoratore, essere l’ultimo e il servitore di tutti; certo che chi lavorava per i po veri, lavorava per Dio. Dopo aver percorso per quasi quarant’anni le strade delle città, i campi e i villaggi di Cordova, con i piedi stanchi e le mani aperte da tanta mendicità, 39 38 qualcuno si ricordò di rendere omaggio al celebre “mendicante di Cordova”, perché il suo lavoro, pur essendo umile e sacrificato, non passava inosserva to. Fra Bonifacio era sulla bocca di tutti e per questo si volle premiare tanto amore e carità disinteressati per i più poveri. Così le autorità cordovane, facendo eco al senti mento popolare, chiesero al governo spagnolo di conferirgli la Croce della Carità, un riconoscimento che veniva dato solo a persone che avevano fatto molto bene al prossimo e che erano un esempio vi vente per gli altri. In questo modo, il governo rico nobbe pubblicamente i suoi meriti e lo ringraziò a nome di tutto il popolo spagnolo. Il riconoscimento gli fu assegnato ad aprile 1972, ma la cerimonia di premiazione fu fissata per il 10 di Fra Bonifacio è decorato con la Gran Croce di benemerenza, 10 dicembre 1972. cembre dello stesso anno. Quel giorno la cerimonia iniziò con una messa concelebrata da dodici sacer doti, presieduta dal vescovo della diocesi di Cordova, Mons. Cirarda, il quale tenne un’omelia piena di affetto per Fra Bonifacio. Al termine dell’Eucaristia, più di due mila persone si erano già radunate fuori dalla chiesa. – L’ex sindaco di Cordova sottolineò nelle sue parole la figura di Fra Bonifacio, il quale, nonostante si creassero situazioni d’imbarazzo, non rinunciava alla sua missione per il bene dei bambini.– Il dottor Calzadilla, direttore medico della clini ca fin dalle sue origini nel 1935, illustrò brevemente la storia del Centro dalla sua fondazione.– P. Jacinto del Cerro, dell’Ordine dei Fatebenefra telli, recitò una bella poesia, seguita da alcune pa Fra Bonifacio in compagnia di Mons. Cirarda, vescovo di Cordova. 41 40 role del Superiore di Cordova, Fra Antonio Barreno, che sottolineò la dedizione di Fra Bonifacio. Dopo la lettura dell’ordinanza di concessione della “Gran Cruz de Beneficencia”, il Governatore Ci vile, D. Manuel Hernández, pronunciò parole com moventi: “All’affetto di Cordova per Fra Bonifacio, il Governo lo sostiene con merito e gratitudine”. Il Su periore Provinciale Sebastián Fernández espresse la sua gratitudine per l’onorificenza conferita a un degno membro dell’Ordine Ospedaliero. Fra Bonifacio concluse, commosso, ringraziando il Governo e tutti i presenti per la calorosa parteci pazione alla cerimonia e per la targa posta “come giusto tributo e affetto fraterno per la sua instancabile carità e dedizione ai bisognosi”. Va detto che, a turno, nelle settimane preceden ti erano arrivate donazioni da parte di benefattori, grandi e piccoli, così che l’umile elemosiniere po teva sentire il “suono” del dono per le necessità dei bambini del Centro. Sappiamo che in seguito, quan do il Provinciale fu informato da un membro della sua comunità che Fra Bonifacio era pronto a “sacrifi care la medaglia” per i poveri, indicò che in virtù del la santa obbedienza doveva essere adeguatamente custodita. 42 SENTIVA PROFONDAMENTE LA SUA VOCAZIONE RELIGIOSA DI OSPEDALIERO Ormai anziano, Fra Bonifacio era assistito da un giovane religioso che faceva l’infermiere nella comu nità cordovese. Il Servo di Dio essendo robusto aveva spesso problemi ai piedi, così a volte questo religioso lo aiutava a pulirsi e a mettersi le scarpe. Il frate però aveva deciso di abbandonare la sua vocazione reli giosa a causa di una donna che gli aveva proposto di sposarlo. E quando si congedò dal buon Fra Boni facio, quest’ultimo, con tristezza e lacrime agli occhi, gli disse: “È deplorevole che tu faccia questo con la tua vocazione religiosa. Anch’io quando ero a Madrid, in qualità di religioso, venni avvicinato con proposte dello stesso tipo, eppure non mi passò mai per la testa di far lo. Ma se Dio lo vuole, Dio sia lodato”. Gli ci volle molto tempo per dimenticare la perdita di questo religioso. Fra Bonifacio non solo dimostrò la sua incrolla bile vocazione, ma la sua testimonianza fu decisiva per attirare nuove vocazioni e per la formazione di nuovi sacerdoti e religiosi. Fra Félix Quintas, che trascorse due anni in comu nità con lui a Cordova, racconta, che quando il Servo di Dio tornava dopo mezzogiorno dall’elemosina di porta in porta, mangiava con la comunità o a un se 43 condo tavolo, e si riposava un po’. Nel pomeriggio era solito pulire i vasi da notte dei bambini ricove rati. Lo faceva quotidianamente come un servizio ospedaliero obbligatorio che si era imposto; era sempre vicino ai bambini, con i quali condivideva aneddoti e scherzi. Faceva questo per consolarli e alleviare loro la nostalgia di casa. Tornando a casa dopo la questua, gli piaceva fer marsi nella stanza dei bambini e, se ne vedeva uno triste, gli chiedeva: “Perché sei triste?” Io non sono mai triste, perché prima che arrivi quel momento, mi racconto una barzelletta e rido”. E il sorriso sboccia va di nuovo sul bambino costretto a letto. Un bacio sulla fronte e diceva: “Pregate Gesù Bambino, perché sia sempre con voi”. Coglieva sempre l’occasione per fare un riferimento al cielo CELEBRAZIONE DEL 50° DI PROFESSIONE RELIGIOSA Religioso capace e socievole, abnegato e sem plice, all’età di 77 anni, il 24 ottobre 1976, celebrò il 50° anniversario della sua professione religiosa, che i confratelli della comunità e la Provincia religiosa festeggiarono con grande partecipazione. Infatti, per tutti i confratelli, secondo le parole del Supe riore Antonio Barreno, Fra Bonifacio aveva qualcosa di più di un normale religioso. Per i confratelli era la memoria vivente di ciò che era stato San Giovanni di Dio. 44 Monsignor Cirarda, celebrò l’Eucarestia e rivol se parole accorate e toccanti al festeggiato e a Fra Antonio Manso, di Cordova, che celebrava il suo 25° anniversario di professione. Concelebrarono anche dieci sacerdoti e animò la santa Messa il coro della scuola apostolica di Cordova. Il Vicario Provinciale, Fra Sebastián Fernández, ricevette il rinnovo dei voti alla presenza di una folta rappresentanza di confra telli delle altre Province di Spagna. La chiesa era gremita, come non mai, e alla fine Fra Bonifacio ricevette i doni dei benefattori, delle comunità rappresentate, del personale del Centro e l’applauso di innumerevoli amici, oltre a quello dei “suoi bambini”, felici di vedere che “Fra Boni” era an cora vivo e attivo e che tutti gli volevano bene. Fra Bonifacio celebra il 50° di Professione religiosa, 1976. 45 ACCIDENTALE CADUTA E ARRIVO AL TRAGUARDO Era il 1978. Il 20 maggio, un giorno come un altro, si preparava ad uscire per la questua. Fra Angel Fonse ca, incaricato dal Superiore ad aiutare il Servo di Dio ormai ottantenne e logorato dal duro lavoro, sentì un forte botto provenire dal bagno, mentre Fra Bonifacio era sotto la doccia. Si affrettò a tornare indietro, si era infatti allontanato per prendere un asciugamano che non si trovava al suo posto, e dovette chiedere l’aiuto di altri due Fratelli. Lo aiutarono ad alzarsi e si resero conto del forte dolore che avvertiva alla spalla destra. Venne fasciato nell’infermeria ed il sospetto di una rottura fu confermata dalle radiografie: frattura del collo dell’omero, e conseguente ingessatura. Fra Bonifacio insisteva per andare a fare il suo lavo ro di mendicante. All’autista Pedro, che non lo vedeva in buone condizioni e lo sconsigliava, rispose: “Devo chiedere l’elemosina tutti i giorni, come fa un povero”. Per questo diceva a coloro che gli stavano ingessan do il braccio: “Lasciate la mia mano libera di chiedere l’elemosina”, e continuava: “Mi basta la mia loquacità”. I confratelli raccontano che non si lamentava mai e con pazienza diceva loro: “Sto perdendo tempo, quello che devo fare è lavorare”, e “quello che man gio non me lo merito”. Un mese dopo era di nuovo in strada, ma questa volta si rese conto che non era più come prima. Tornato a casa, poiché non si sentiva bene, fu portato in reparto e messo a letto. I medici che lo visitarono furono chiari nella loro diagnosi: si trattava di una trombosi cerebrale. Ma questa volta si riprese grazie alle sue forze. 46 Qualche giorno dopo ricominciò la sua attività di questuante per “i suoi figli” attraverso il telefono. Molti benefattori si interessarono a lui e gli lasciaro no la propria donazione, che lui a sua volta conse gnava al Superiore. Si spense lentamente. Nei momenti di lucidità, ebbe a dire. “Ieri sera pensavo di morire, ma ho sentito tanta dolcezza e pace che non ho dubbi che il Signore stia preparando un felice passaggio verso di lui”. E n trò in coma, ma riprese conoscenza ed era ancora in grado di dire a Fra Angel: “Se non siamo uomini di preghiera, la nostra vita va a rotoli”, come aveva detto molte volte durante la sua vita. “Ho già compiuto la mia missione, che Dio mi chiami quando vuole”. DESTINATO AL CIELO Verso le tre del pomeriggio dell’11 settembre 1978, Fra Bonifacio Bonillo morì serenamente nell’O spedale San Giovanni di Dio di Cordova. La notizia si diffuse in tutta la città. Anche la comunità e i bambini piansero e pregarono molto per lui. Non avrebbe più chiesto l’elemosina. Coloro che lavoravano presso la stazione radio e la redazione giornalistica, i benefat tori e tutti gli abitanti di Cordova sfilarono davanti alla salma di Fra Bonifacio. I fratelli giunsero da tutte le case dell’Andalusia e da Madrid. Mons. Infantes Flori do, presiedendo l’Eucaristia, disse nell’omelia: “Era un uomo semplice che offriva la sua vita, il suo buon umore e il suo sorriso come testimonianza della sua dedizione agli altri. Non escludeva nessuno e non distingueva le persone in base alla loro classe sociale. Per lui tutti era no uguali e si rivolgeva a tutti chiedendo per i suoi figli”. 47 Dopo il funerale i suoi resti mortali furono trasfe riti nel cimitero di San Rafael, nella città di Cordova, e collocati nella cappella dei Fratelli di San Giovanni di Dio, nel cortile principale del cimitero. Tomba dei Religiosi dove venne sepolto il Servo di Dio.
TORNA IN OSPEDALE Dopo la morte, la sua fama di santità continuò a crescere, così come l’Opera sociale, a lui dedicata, proseguì a svolgere la propria missione di servizio ai più bisognosi di Cordova e ad intensificare l’attività ogni anno a causa delle difficili condizioni di molte famiglie prive dei beni di prima necessità. Finché ci sarà qualcuno nel bisogno, i Fratelli di San Giovanni di Dio, fedeli seguaci del Santo della Carità e impegnati continuatori del servizio che Fra Bonifacio ha sempre voluto prodigare oltre l’impos sibile, manterranno attivo il servizio sociale, con lo spirito di solidarietà e generosità di tutti gli abitanti di Cordova che ancor oggi continuano con genero sità a donare quanto necessario. Traslazione delle spoglie mortali di Fra Bonifacio per il centenario della nascita, 1899-1999. 49 48 Nel 1999, in occasione del centenario della na scita dell’amato Fra Bonifacio, dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni, si decise di riesumare i resti che erano stati deposti nel cimitero di San Rafael dopo la sua morte. Nel mese di marzo del 1999 vennero sottoposti a un accurato studio ana tomopatologico e debitamente conservati furono traslati nella cappella dell’ospedale San Giovanni di Dio, dove attendono la resurrezione e la desiderata glorificazione. Da allora molte persone continuano il loro pellegrinaggio per chiedere favori e grazie al Signore per intercessione del Servo di Dio. Il nostro Fra Bonifacio continua a sperare che, quando lo visitiamo e lo preghiamo, ci ricordiamo dei poveri e dei sofferenti, soprattutto dei bambini, per i quali ha sempre fatto tutto per amore di Dio. Tomba del Servo di Dio nella Chiesa dell’Ospedale San Giovanni di Dio a Cordova, dopo la traslazione nel 1999. LETTERA DEL VESCOVO CIRARDA Quando Mons. Cirarda era vescovo a Cordova, nel 1972 partecipò alla cerimonia di conferimento della “Gran Cruz de Beneficencia”, vivendo momenti di vera vicinanza cordiale e fraterna con Fra Boni facio. In occasione del centenario della nascita del Servo di Dio, nel 1999, il vescovo si scusò di non po ter partecipare a causa di altri impegni, ma scrisse una bellissima lettera al Superiore della Comunità di Cordova. “Le sono grato per la sua gentilezza per avermi invi tato ad onorare il caro Fra Bonifacio a Cordova il pros simo 20 maggio. Ho un ricordo molto bello della bontà di questo Fratello. Ho avuto molti contatti con lui nei giorni, ormai lontani, del mio servizio episcopale in quella Chiesa di Cordova, per me indimenticabile. E ricordo con commozione le tante virtù del suddetto Fratello, l’amore con cui si prendeva cura dei malati, soprattut to dei bambini, e il coraggio con cui osava tutto per servirli, al di là di quanto la prudenza umana potesse consigliare. Il suo spirito mi è sempre sembrato “una controfigura”, come si dice nel lessico cinematografico, dello spirito di San Giovanni di Dio, la cui vita e il cui esempio lo avevano sedotto a imitare Cristo, seguen do le orme di quel “pazzo d’amore” che stupì Granada. Onorando Fra Bonifacio, Cordova onora sé stessa, adempiendo a un dovere di gratitudine nei confronti di un così buon servitore di Dio e dei poveri, che era 51 50 considerato “folle d’amore” e “Fratello” di tutti a Cor dova. Avrei voluto essere con voi il 20, per ricambiare l’o nore che mi avete fatto invitandomi. Ma non posso. Sono in pensione e molto anziano. Ma sono in buona salute e mi muovo molto a causa dei continui impe gni apostolici. Come le ho detto al telefono, per tutto il mese di maggio sono impegnato nel lavoro pastorale in Catalogna, Navarra e Vitoria. Mi unisco spiritualmente a voi nel ricordare Fra Bonifacio. E le sarei grato, se fosse così gentile, al mo mento opportuno, di rendere nota la mia vicinanza a tutto il popolo di Cordova nel giusto omaggio che gli renderà. Un saluto e una benedizione a tutti i Fratelli”. José M. Cirarda–––––– Per la bontà del suo contenuto, riportiamo qui anche un’altra lettera di Monsignor Cirarda, al quale Juan Muñoz Cascos, autore del libro “Excelentísimo Señor Limosnero”, aveva inviato una copia. Di segui to la risposta da Pamplona 4 marzo 1985: “Mio caro amico: Lei si è fatto onore omaggiando l’Eccellentissimo Signor Limosnero, Fra Bonifacio, de dicandogli un libro ampio e ben documentato, che mi sembra colga lo spirito di quell’uomo di Dio, insigne benefattore di Cordova, nato in Castilla la Nueva, ma cordovano nel cuore fin dal suo arrivo in quella città del Califfato. 52 L’ho conosciuto da vicino durante gli anni in cui ero vescovo di Cordova. Ho avuto molti rapporti con lui. Ho ammirato le sue grandi virtù umane e religiose. Sono testimone di come si sia sempre prodigato af f inché la Clinica di San Giovanni di Dio raggiungesse l’eccellenza nei suoi servizi, che la caratterizzano. Per questo motivo, sono stato molto contento di poter partecipare in due diverse occasioni a due omaggi che gli sono stati tributati durante i miei giorni a Cordova. Ho letto con interesse il lavoro che gli avete dedica to. Spero che serva a due scopi:– affinché non si dimentichi la figura di quell’uomo buono, con il temperamento di un santo, inciso in lui, che nell’antica Cordova diede frutti esemplari di carità e di giustizia sociale; e – perché il ricordo della sua figura sia di stimolo af f inché la sua opera rimanga, perché non manchino generosi cordovesi che continuino a percorrere la strada che lui ha tracciato con la sua ammirevole dedizione caritatevole. Le, sono molto grato per avermi inviato il libro e per l’affettuosa dedica che ha voluto farmi. Prego Dio che ci siano molti cordovesi, che amino ricordare personaggi degni di merito, che spesso per la nostra fragilità ed egoismo cadono nell’oblio. Che tu possa avermi sempre come tuo affettuoso amico. Che tu sia benedetto. José Mª Cirarda, arCivesCovo PREGHIERA DI INTERCESSIONE Signore Gesù Cristo, conforto dei deboli e degli oppressi, che hai annunciato il tuo Vangelo della Misericordia, attraverso la testimonianza e le opere di carità di Fra Bonifacio, fedele imitatore di San Giovanni di Dio, fa che otteniamo per sua intercessione le grazie che ti chiediamo e in particolare quella di (dire la grazia che si desidera ottenere), perché seguendo il suo esempio possiamo amarti al di sopra di tutte le cose del mondo e possiamo sempre servirti nei nostri fratelli e sorelle più bisognosi e malati. Signore nostro Dio, ottienici le grazie che ti abbiamo chiesto per la tua maggiore gloria e il tuo onore. Per Cristo nostro Signore. Amen. (Padre nostro, Ave Maria e Gloria) Con l’approvazione ecclesiastica Secondo i decreti di Urbano VIII 54 ITINERARIO DELLA VITA DI FRA BONIFACIO 1. Cañaveruelas. Bonifacio Bonillo nacque il 14 maggio 1899. Rima sto orfano all’età di dieci anni si dedicò a lavorare nel piccolo orto di proprietà per trarre sostentamento alla famiglia. Fu un giovane gentile e allegro con tutti. 2. Barcellona. Nel 1923, poiché era stato esonerato dal servizio militare, in quanto figlio di madre vedova, si mise alla ricerca di lavoro e dopo aver girovagato senza fortuna per Madrid e Saragozza, arrivò a Barcello na dove trovò un impiego come fattorino presso il “Centro de la Inmaculada”, gestito dai Fratelli di San Giovanni di Dio, che si occupava di bambini poveri. 3. Ciempozuelos. Entrò come postulante a Ciempozuelos (Madrid), nel Sanatorio psichiatrico di “San José”, dove i reli giosi accoglievano e curavano più di 1.300 malati di mente. Fu la prova vocazionale decisiva, che lo con fermò nella sua chiamata all’ospitalità. 4. Carabanchel Alto. In questo luogo, vicino a Madrid, fece il novizia to (1924-1926) e la professione semplice dei voti di 55 povertà, castità, obbedienza e ospitalità (1926). Tra scorse il suo tempo in ospedale con un centinaio di ragazzi epilettici ricoverati presso l’istituto “San José”. 5. Santurce. Nel 1926 a Santurce (Bilbao), nell’ospedale San Giovanni di Dio, ricevette il suo primo incarico come inserviente dell’ospedale per dieci intensi mesi. 6. Madrid. Nel Centro “San Rafael”, per i bambini affetti da po liomielite, svolse il suo lavoro più faticoso come eco nomo per quattro anni (1927-31), e dimostrò la sua grande vocazione per il servizio ospedaliero, metten do alla prova la sua forza d’animo e la sua virtù. 7. Granada. Dal 1931 al 1935 trascorse un periodo a Granada dedicandosi alla questua per la città e alla cura dei bambini poveri e paralitici. 8. Cordova. Con il suo arrivo a Cordova, nel 1935, crebbe il nuovo Centro “San Rafael”, dove si dedicò con umile disponibilità alla questua, percorrendo città e vil laggi per 43 anni, sviluppando le sue virtù cristiane, facendosi fratello di tutti, soprattutto dei più poveri e malati, consumando la propria vita per i “suoi po veri figli”. Nel 1972 il Governo Spagnolo gli conferì 56 la Gran Croce di benemerenza per il suo impegno di carità verso il prossimo. Morì in fama di santità l’11 settembre 1978 nell’ospedale San Giovanni di Dio di Cordova. Il 18 dicembre 2022 nella Diocesi di Cordova inizia la Causa di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio. 57 58
Indice Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 3 Il centro dell’Immacolata Concezione . . . . . . . . . . . . . 7 La situazione in Spagna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 L’influsso di San Giovanni di Dio. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Ingresso nell’Ordine Ospedaliero . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Professione dei voti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 L’ospedale San Rafael a Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 A Granada da San Giovanni di Dio . . . . . . . . . . . . . . . 22 Cordova una clinica accogliente . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Questuante a Cordova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 È conosciuto come “Fra Garbanzo” . . . . . . . . . . . . . . 27 L’arte di essere elemosiniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Non aveva barriere nel “chiedere per amore di Dio” . . 32 Asta di beneficenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 La popolarità di Fra Bonifacio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 La croce di benemerenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Sentiva profondamente la sua vocazione religiosa di ospedaliero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Celebrazione del 50° di Professione religiosa . . . . . . 44 Accidentale caduta e arrivo al traguardo . . . . . . . . . 46 Destinato al cielo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Torna in ospedale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Lettere del vescovo Cirarda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Preghiera di intercessione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Itinerario della vita di Fra Bonifacio . . . . . . . . . . . . . . 55
Filed under: Senza Categoria | No Comments »