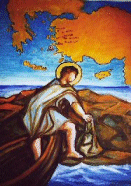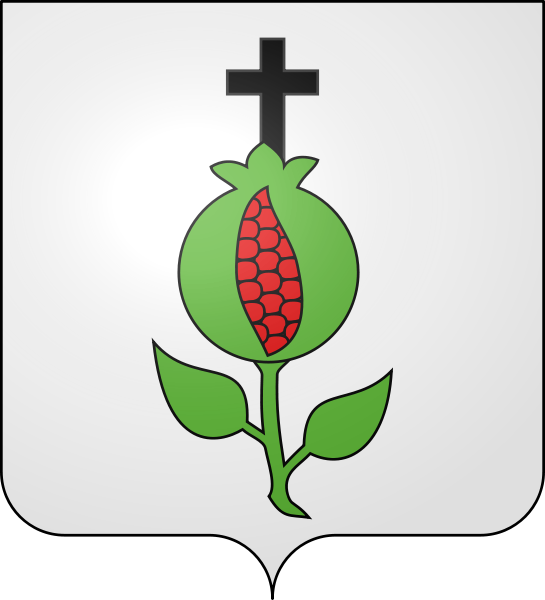Don Mazzolari: “Impegni cristiani, istanze comuniste”. Un saggio forse attuale, senz’altro stimolante

Impegni cristiani istanze comuniste
Saggio tratto da “Cattolici e Comunisti”, ed. La Locusta, 1978
di Primo Mazzolari
Il malcontento, oggi, ha un nome, la novità un volto: comunismo.
In questo senso, comunisti lo siamo un po’ tutti: anche coloro che ne hanno paura e ne dicono male.
Se vogliamo veramente qualche cosa di diverso di quanto è stato fatto sin qui, è bene che ci disponiamo a fare un po’ di strada con i comunisti.
Perché se il comunismo è quella dottrina politica con premesse filosofiche e previsioni economiche ben determinate e con prassi rivoluzionaria che va dalla dialettica o lotta delle classi alla loro cancellazione attraverso una più o meno lunga dittatura del proletariato: se il comunismo è questo o quel partito operante in questo o quel paese, oggi è soprattutto uno « stato d’animo » di rivolta contro il male sociale di qualsiasi nome, un interiore tempo d’avvento, l’attesa di una novità che, senza farci dimenticare le sofferenze patite, renda impossibile il loro ripetersi.
Pochi, credo, anche fra gli intellettuali che simpatizzano con il comunismo e tra gli stessi militanti, conoscono bene la struttura dottrinale e il meccanismo politico del comunismo. Parecchi non hanno neppure voglia di conoscerlo; mentre sono disposti a lasciarsi condurre, almeno inizialmente, da un movimento, che dà voce e concretezza alla loro coscienza umana, cui vogliono essere fedeli per non tradire un impegno reso sacro dai patimenti e dalla morte di milioni di uomini.
Ecco perché, al confronto con le dottrine comuniste, lavoro assai spedito ma di scarso rendimento, preferisco mettermi vicino, come cristiano, a questo « stato d’animo »‚ che costituisce la forza segreta del comunismo e che non fu mai così vasto, così esigente, così esasperato.
Chi ci impedirà di ricostruire la « città » sui piani di ieri, non sarà il dottrinalismo degli iniziati, ma l’opposizione irresistibile, anche se anonima, di tutti coloro che hanno ineffabilmente scontato i crolli di un mondo costruito sull’ingiustizia.
E se badiamo all’« animo » prima che alla « dottrina »‚ ciò non vuoi dire che diamo poca importanza ai principi: ma perché se il mondo oggi fermenta e si muove, fermenta e si muove non in virtù di un pensiero concreto e organizzato, ma di un sentimento forte e fluidissimo, nel quale va prendendo dimora una strana famiglia di altri sentimenti, che, pur essendo a volte in contrasto con la dottrina comunista, almeno quella dei libri, non lo sono affatto con 1’«animo»‚ in cui il comunismo si è potentemente insediato e quasi confuso. Mi pare un grande fenomeno d’invasione in terra di nessuno, benché il sentimento che ci travaglia sia un fatto di comunione più che di comunismo.
S’impone quindi lo studio di questo sentimento, il cui significato rivoluzionario è così impressionante che i pochi che stanno ancora bene ne sono ossessionati, trascinandosi dietro una variopinta turba di pavidi che temono di vedere il mondo finire perché domani invece di «camerata» ci chiameremo «compagni».
Urge questo studio, se vogliamo capire il popolo e impedire che venga condotto su strade che non sono le sue, e dietro dottrine dalle quali solo con fatica e a caro prezzo ci potremo liberare.
La forza del comunismo non è legata a nessuno dei suoi postulati dottrinali – non al materialismo dialettico né a quello storico, non alla lotta di classe né all’abolizione di essa attraverso la dittatura del proletariato – ma alla fede nell’avvento di una giustizia sociale che faccia respirabile per tutti l’aria di quaggiù.
Sono pochi i comunisti militanti che comprendono la funzione della dottrina marxista, ancora più pochi coloro che sono disposti a dare la vita per testimoniare che il processo economico risolutivo della rivoluzione si svolgerà sui binari tracciati da Marx e da Lenin: mentre sono molti i comunisti che in questi anni hanno testimoniato per la libertà e per la giustizia nelle carceri, nei campi di concentramento, davanti ai plotoni d’esecuzione.
La dottrina comunista, troppo filosofica e troppo storica, e quindi sottoposta a tutte le incertezze della filosofia e alle vicissitudini della storia, non può appassionare che per l’elemento mitologico di una beatitudine terrena assicurata a tutti.
Il comunismo vuole il bene dell’uomo, ne cura e ne esalta il valore, e all’improvviso pare che lo dimentichi, sommergendo la persona nella collettività, alla quale, senza volere, dà un significato religioso, facendo in essa la trasposizione terrena della «Gerusalemme celeste» di cui godranno soltanto le generazioni, che abiteranno la terra quando la nuova dimora umana vi sarà durevolmente stabilita.
L’elemento materialistico non fa religione neanche nel comunismo, a meno che non lo si guardi come accettazione disperata di una realtà senz’altra dimensione. Diviene quasi religioso per la sete di giustizia che lo tormenta e per il coraggio veramente disperato di volerla interamente quaggiù, ove il predominio della materia e la brevità dell’uomo la rendono un’impresa assurda. Questa vita, sia pure in un congegno sociale più umano del presente, lascia troppo di scoperto e di vuoto nel nostro cuore.
Non c’è nessuno che non arrivi come un defraudato alla fine di un viaggio che pare piuttosto un’introduzione.
La visione di un’umanità felice è indubbiamente religiosa: ma la beatitudine che ci viene offerta dal comunismo è fatta di limite più che di espansione, di rassegnazione più che di slancio, ed è destinata a divenire tragicamente statica per non mettere a repentaglio una felicità, fragilissima per natura, e quasi imposta da un sistema esteriore e da un’interna mutilazione. Dove finisce l’avventura non è detto che cominci il paradiso. Una civiltà, anche grande, che mutili l’uomo, costruisce contro l’uomo e contro quell’unico sentimento che è la forza della rivoluzione comunista come della rivoluzione cristiana.,
Dopo questo preciso e sobrio confronto, per il quale non mi fu necessario impegnare grosse firme né ricordare esplicitamente nessuna definizione, credo di poter usare verso i comunisti la più grande lealtà e la più franca amicizia, rimanendo inconfondibile la mia fisionomia cristiana.
Conosco individui lealissimi, nei rapporti di persona a persona, che non lo sono affatto nel giudicare o trattare istituzioni, partiti, comunità. Non essendovi di mezzo un interesse personale, non si sorvegliano, e conducono la difesa e l’attacco «ad abundantiam». Le passioni collettive, gravide di errori e di orrori, sono le meno controllabili, e molta brava gente si vanta di metodi, di cui si vergognerebbe se li usasse per difendere qualche cosa di suo. E così facile divenire partigiano e settario: due scogli che sono certo di poter evitare, per la stima e l’amicizia che mi lega a molti comunisti. Chi non è benevolo non può essere leale.
La lealtà è frutto di carità.
Il comunismo è uno dei tanti movimenti politici che si sono succeduti in Europa dopo la rivoluzione francese. Ebbe una lunga incubazione dottrinale e sviluppi storici scarni e faticosi agli inizi: un’affermazione imponente e quasi improvvisa nella rivoluzione bolscevica: una disposizione d’animo larga e profonda oggi, preceduta e accompagnata da testimonianze eroiche nell’esilio, nelle prigioni, nei campi di concentramento, sui patiboli.
Basterebbe questa testimonianza, numerosa e nobilissima, a farci riverenti e pensosi. Quando un’idea è suffragata dal sacrificio (la parola « fanatismo » va usata con estrema parsimonia), bisogna parlarne con rispetto, anche se molti aspetti di essa urtano le nostre più care certezze.
« Il comunismo è avversato da tanti… »‚ si dice.
Ma tutti i movimenti che si dichiarano contro interessi, consacrati dal tempo e dal diritto, e che di questa loro netta opposizione ne fanno un postulato, suscitano timori, denigrazioni, odi implacabili.
Chi sta bene s’è anche procurato degli amici, o se li può, all’occorrenza, procurare col nome, il denaro, la prepotenza, la propaganda, l’astuzia: proclamandosi, all’improvviso, patrocinatore di quelle cause e di quegli interessi, che avendo legami con profondi sentimenti naturali – religione, patria, famiglia – sono condivisi da molti.
Ed ecco lo spettacolo, poco edificante ma istruttivo, di uomini senza fede che si dichiarano per la religione; di senza patria che s’accendono di furore nazionalistico; di corrotti celibatari che esaltano la santità della famiglia.
Gli ingenui e i timorati si commuovono davanti al miracolo, e la «crociata» viene proclamata «pro ans et focis» contro il nemico comune.
E chi ne paga lo scotto sono i cristiani, che, per delle verità che non vanno difese in quel modo né in quella compagnia, si assumono la tremenda responsabilità di puntellare un ordine sociale, che è la negazione dell’ordine cristiano.
La nostra paura è quasi sempre il riflesso della paura dei benpensanti, i quali sono riusciti a reclutare le loro migliori milizie tra il popolo fedele e a dare battaglia, la loro battaglia, fino all’ultimo cattolico.
Ma io volevo soltanto ricordare – poi la penna ha camminato per suo conto – che se c’è qualcuno che non deve lasciarsi impressionare dal clamore anticomunista siamo proprio noi, che possiamo vantare tre secoli di sollevazione di tutte le forze conservatrici del mondo pagano, e una storia le cui pagine più belle sono il racconto delle persecuzioni patite.
La Chiesa c’insegna che non è sempre il male che desta odi inestinguibili.
E allora, sia pure per curiosità, vien voglia di vedere con i propri occhi «questa gente in odio al genere umano». Molte conversioni al cristianesimo nacquero da questa onesta curiosità.
Chi sono questi comunisti?
Di quelli russi riporto il giudizio di un foglio di propaganda cattolico: «Indubbiamente la loro vita, segnata durante il regime degli zar da persecuzioni, prigionie, esili, tutta spesa per la causa del loro partito, senza che vi appaia l’ombra di un qualunque interesse personale, ha degli aspetti di eroismo. La persuasione che hanno di una grande missione da svolgere nel mondo mette nella loro attività una tenace costanza che li accompagna assiduamente al lavoro. Cosicché, mentre a un occhio nemico possono parere addirittura brigantesche, diaboliche le loro azioni, a un occhio amico possono invece sembrare degne di quella ammirazione che gli uomini riservano per i grandi benefattori».
Un occhio cristiano, se vuole essere giusto, non può essere che un occhio amico.
Nomi di comunisti italiani arrivati a rinomanza non ne conosco: conosco però molta umile gente, gente del popolo, che in questi anni riempirono i campi di concentramento e le carceri e seppero morire per la loro fede con nobile fermezza.
Mi si potranno opporre figure e imprese di tutt’altro genere, con l’accompagnamento di una sbalorditiva documentazione. Ne prendo nota, senza negare: non voglio negare. Ricordo però che la propaganda documentaria sa fare le cose così grandiosamente e pulitamente che ci vorranno anni e anni per ricondurre certi avvenimenti nelle loro giuste proporzioni.
Del resto il mio ufficio non è né di accusare né di scusare. Vi sono torti che non si potranno cancellare: ma gli accusatori, certi implacabili accusatori, non hanno le mani pulite, e i loro delitti sono almeno altrettanto abbominevoli, senza l’attenuante di una sofferenza secolare sulle spalle, di una risposta degli oppressi alle crudeltà degli oppressori, di un impegno folle e sublime di realizzare a qualunque costo una specie di paradiso terrestre.
«Non m’importa di uccidere in dieci anni, dieci o più milioni di uomini, purché fra cento anni, centocinquanta milioni di uomini siano felici» (Lenin).
Il proposito è disumano, ma sono forse più umani i propositi non confessati che portarono alla morte fra stenti fatiche miserie e guerre milioni e milioni di uomini per difendere il benessere o coprire di gloria una classe che non è sempre la più meritevole?
Noi condanniamo la violenza, l’odio, il male, le vendette, comunque e da chiunque commesse, ma fra la rivolta degli oppressi e la tirannia degli oppressori non possiamo non avvertire una differenza e valutarla nel nostro giudizio morale.
Cosa vogliono i comunisti? La fine delle ingiustizie e la felicità di tutti gli uomini.
Cosa vogliono i cristiani? La fine delle ingiustizie e la felicità di tutti gli uomini.
La differenza è sui mezzi e sul modo di concepire il bene, conseguenza di una diversa visione dell’uomo e della vita.
Circa i mezzi: quando sono malvagi, non c’è modo d’intendersi. Però, sé vogliamo essere equi, domandiamoci quali sono i partiti che non abbiano usato e non usino o non siano disposti ad usare mezzi che la nostra coscienza non disapprovi.
La Chiesa ha sempre dovuto fare riserve e formulare condanne nei confronti di tutti i regimi, non esclusi i «cristianissimi» e i «cattolicissimi».
Nessuno, ad esempio, nega l’uso della forza. Ne ha bisogno anche l’uomo retto per riconoscere dove finisce il proprio diritto e incomincia il proprio dovere, perché il bene comune non può essere abbandonato all’arbitrio o alla ispirazione del singolo. Ma quando la forza cessa di essere una nota che può incastonarsi nella virtù della fortezza e si tramuta in quella ripugnantissima cosa che si chiama violenza?
Purtroppo siamo avvezzi a chiamare forza la violenza legittima, quella che in certo qual modo è riuscita a darsi un abito e un passo di buona creanza legale: mentre la forza che cerca di svincolarsi dall’oppressione legale, siccome è contro la legge dettata dagli oppressori, è violenza.
Se l’oppresso, per difendere un suo valore umano, assale il proprio oppressore, è un violento: mentre la rappresaglia, voluta da un editto per cui dieci cittadini innocenti pagano con la propria vita un tentativo di liberazione, è un uso legittimo della forza.
’Chiudo la serie degli esempi, che potrebbe divenire lunga e piena di sorprese, con una breve considerazione.
In un regime iniquo, sia per liberarsene come per moderarlo, è difficile usare mezzi che non lascino almeno perplessa la nostra coscienza. Con questo non si vuole dire che ci siano due morali, una per l’individuo e una per l’uomo associato, ma che in contingenze estreme per la tutela del bene comune l’uomo politico più integro può essere messo nell’alternativa penosa di scegliere non tra un bene e un male ma tra un male minore e un male maggiore. E allora, non rimane che disertare il proprio posto o affrontare l’agonia che è tale appunto perché invece di velare il male lo statista cristiano consapevolmente lo condanna onde avere la forza di non usarlo oltre la triste necessità.
Si è più fedeli al bene comune e alla propria coscienza disertando o agonizzando sul posto? Non rispondo, perché non so. Questo so: che la cristianità ha duramente scontato le diserzioni poco illuminate e troppo applaudite da quell’opinione devota che non osando affrontare i duri aspetti della realtà politica passa dal giudizio severo all’indulgenza più larga.
La dottrina comunista è essenzialmente impregnata di materialismo.
Il materialismo – si tratta di un materialismo affatto volgare, che s’accompagna con un senso vivo dell’ideale, della grandezza e del sacrificio – viene accettato dal comunismo come l’espressione superiore e definitiva della verità e gli fa da cardine, come l’affermazione di Dio fa da cardine al cristianesimo.
E come nella nostra religione tutto viene da Dio e tutto a lui si riconduce, così nel comunismo tutto dipende dalla materia e alla materia ritorna.
Rinunciando alla beatitudine eterna, il comunismo non ha potuto rinunciare alla beatitudine terrena, ch’egli inserisce nella sua struttura filosofico-scientifica con la stessa passione e la stessa fede con cui nella visione cristiana s’inserisce il Regno dei Cieli.
Il comunismo, benché cammini dietro la stessa sete di giustizia e di elevazione umana del cristianesimo, fa colpa alla nostra religione di trasferire il raggiungimento pieno della felicità in una vita ultraterrena inesistente, oppio dei poveri a beneficio dei ricchi, enorme ostacolo allo sforzo vitale per il raggiungimento del benessere umano.
L’antitesi è netta e senza conciliazione finché il comunismo rimarrà legato alle sue non necessarie premesse materialistiche.
Il fatto è grave e non ci lascia indifferenti: non è però il caso di sgomentarci, né di metterci a gridare parole dissennate sia pure per dare l’allarme e premunirci. Mi pare che si faccia più tragedia di quanto convenga, e senza alcun tornaconto, se non quello di mostrare la nostra poca fede e di chiamarci intorno ausiliari che moltiplicano la nostra paura e che ci fanno ripiegare su trincee che non sono le nostre, imprestandoci interessi e linguaggio e argomenti che non possono convenire alle grandi cause dello spirito.
Pare la prima volta che la nostra religione si trovi di fronte ad una visione materialistica della vita. Sono forse diverse, se sappiamo leggere oltre le parole, le posizioni di quelle filosofie che hanno sorretto e sorreggono molti movimenti liberali e democratici? Il paganesimo non è forse l’anima occulta di molti regimi che solo a motivo di un linguaggio riguardoso e di una tattica diplomatica si guadagnarono particolari benevolenze in campo cristiano?
Raramente una vetta si staglia da sola: cime e vette minori la preparano e le fanno corona. Il materialismo comunista, così preciso e sicuro in ogni suo particolare, è la logica conclusione di un travaglio secolare dello spirito umano, che dal Rinascimento in poi ha preso un moto accelerato fino a tentare una soluzione integrale della vita favorito dalla decadenza della spiritualità cristiana e dall’arresto della sua influenza sulla politica, sull’economia e sulla cultura europea.
Al principio, il dibattito si svolse dentro le frontiere cristiane con carattere ereticale: poi, in margine: infine, dichiaratamente contro le nostre insegne fino a stabilire le strutture teoriche e i preliminari pratici di quel nuovo ordine e di quella nuova religione in cui l’uomo di oggi e di parecchie altre generazioni viene sacrificato all’uomo di domani, un regno di felicità che pare quasi toccabile e alla portata di tutti mentre è ancora molto ipotetico e un po’ meno amabile del Regno dei Cieli.
E vero che la tendenza materialistica è quasi congenita: ma alle sue ultime conclusioni più che per voglia ci si arriva per disperazione allorché la strada dello spirito pare chiusa o ci viene indicata da voci inconsistenti che dicono e non fanno.
La responsabilità va almeno ripartita e a chi non è senza peccato conviene un tono meno concitato e severo.
Finora, con tanto parlare, non si è fatto nessun guadagno, e l’animo se non la dottrina comunista ha dilagato favorito da un’opposizione più violenta che illuminata e da bagliori polemici in cui la letteratura occasionale ha giocato con fantasie equivoche ma ben pagate.
«Roma o Mosca» è uno dei tanti luoghi comuni di questa polemica senza fede e senza intelligenza, che, invece di chiarire, portò confusione, istituendo tragiche antitesi, che la storia non riconosce, molto meno la storia della Chiesa.
I primi cristiani non hanno accettato gli aut aut cari ai retori di ogni tempo: Gerusalemme o Atene, Gerusalemme o Roma, e neanche Cesare o Pietro, poiché gli elementi di verità e di bontà ovunque sparsi si possono e si devono ricapitolare nella cattolicità, che ne ha la funzione e la capacità.
Più tardi, per lo stesso motivo, venne rifiutato Wittemberg o Roma, Ginevra o Roma. Se tutte le strade portano lontano da Roma («los von Rom») tutte le strade vi possono condurre («nach Rom»). Tale animo, e la condotta che può ispirare, mi sembrano un po’ diversi dalla politica della «mano tesa»‚ che potrebbe essere un corto calcolo di ambedue. La salvezza non può venire da un opportunismo tattico, ma da una risoluzione sincera e spassionata in nome del bene comune attraverso un’esperienza che tanto noi quanto i comunisti avremmo già dovuto avviare. Camminando s’impara a camminare.
Nessuna coercizione potrà impedire al comunismo di camminare.
Non c’è riuscito il formidabile schieramento nazi-fascista: non ci riusciranno i loro epigoni sparsi un po’ dappertutto.
Così nessuna organizzazione e nessun successo potrà impedire lo sfaldamento del materialismo, che è piuttosto una camicia di forza destinata a saltare sotto la pressione del respiro eterno dell’uomo che vi sta dentro a fatica e vi si sente soffocare.
Molto più che il comunismo, accrescendo nell’uomo l’anelito verso la giustizia, favorisce proprio quella forza che da sola sconvolge ogni limite della materia. Non si può riconoscere all’uomo dignità e grandezza, per poi imprigionarlo in uno spazio che non è il nostro spazio vitale.
Per conseguenza, anche le ipotesi di carattere economico-sociale, quand’anche s’avverassero, non darebbero i risultati promessi, perché l’uomo, nella concezione comunista, è collocato in una realtà troppo raccorciata.
Nessuno può tagliar fuori il mistero dal cuore e dalla strada dell’uomo senza renderlo incommensurabilmente infelice e pericoloso.
E il mistero non è un’aggiunta o un regalo della fantasia: è dentro di noi, connaturato in noi: fermento di quel Regno che non abbraccia soltanto la terra.
Esso opera già. Le «evoluzioni» che sono nel movimento comunista, anche se screditate dai settari di fuori e osteggiate dai settari di dentro, sono le necessità imposte non da un destreggiamento tattico verso le abitudini o le tradizioni, ma dalla natura stessa dell’uomo, che il cristianesimo ha preso in mano integralmente. I
La Chiesa ha condannato il comunismo ateo e materialista.
Aggiungo: ne aveva il diritto e il dovere, e mi vergognerei di allineare testi contro testi per negare o minimizzare il valore della condanna: come si dovrebbero vergognare coloro che ne estendono il significato credendo di rendere omaggio alla Chiesa mentre rendono omaggio agli interessi di qualcuno contro gli interessi dei poveri.
La nostra apologetica si è fatta eccessivamente debitrice della retorica borghese, dimenticando che noi non abbiamo interessi di classe da difendere, ma valori che convengono a tutti gli uomini.
La condanna dottrinale crea l’antitesi tra il cristianesimo e il comunismo: ma nessun comunista intelligente e retto s’illuse mai che la sua concezione materialista della vita e della storia, sia pure con l’intenzione di far meno infelice l’uomo, potesse essere sopportata dalla Chiesa. Ma la condanna – e lo ricordino i massimalisti e gli zeloti – non va più in là, conglobando, come pare che molti facciano, nello stesso giudizio di riprovazione, la sete di giustizia che muove il comunismo e il suo lodevole sforzo verso un riordinamento sociale.
L’urto si profila quando dei cristiani, invece di leggere la condanna come una regola di orientamento a un’azione sociale veramente cristiana, si riparano dietro le encicliche e i messaggi, per disimpegnarsi e per continuare a sparare contro il «nemico»‚ invece di superarlo, costruendo sulla roccia invece che sulla sabbia.
L’edificare sulla sabbia è un infelice mestiere: ma io credo che tra coloro che disponendo della roccia non scavano fondamenta né alzano un muro paghi di magnificare la saldezza del loro terreno e coloro che in qualche maniera s’adoperano a costruire sia pure su terreno friabile siano preferibili questi ultimi. Sono almeno uomini di buona volontà, che non seppelliscono il « talento ». La verità, che si compiace di contemplarsi, è come la fede senza opere, cosa morta: e anche i poveri finiranno per preferire un « errore » che si adopera in loro favore a una « verità » che non s’accorge di essi.
Le critiche di carattere scientifico al comunismo non vanno confuse con quelle di ordine religioso. Non si demolisce una fede, neanche la fede comunista nell’avvento della giustizia, con argomenti tecnici. Il valore di certe esperienze, anche se suffragate da abbondanti statistiche e da ricorsi storici, è molto dubbio. Si può sempre dubitare della maniera con cui esse furono condotte. Il capitalismo paga bene gli uomini di scienza…
Nessuno deve pensare che anche noi facciamo coro e prendiamo il tono da coloro che hanno paura del comunismo perché sono ricchi.
Il pericolosissimo gioco di stare insieme a guardare è durato fin troppo. I figli delle tenebre, sempre più accorti dei figli della luce, ci hanno subito mobilitati e spediti in prima linea a difendere una proprietà che non è la proprietà in senso cristiano, un ordine che non è il nostro. Ora, essi facciano la loro guerra: noi la nostra. Tanto più che la condanna dottrinale del comunismo ci crea un impegno urgente e gravissimo:
dimostrare che si può ricostruire cristianamente il mondo senza rinunciare a nessuna esigenza di giustizia terrena.
Chi sente questo impegno con passione, non ha bisogno di molte e dettagliate norme. Le poche cose che oso proporre sono semplici indicazioni, che potranno essere riscontrate utili anche da chi non ne ha bisogno.
Vi sono « novità » che agli intelletti pigri e abitudinari paiono sulle prime inconciliabili con la religione e che, a ragion veduta, assai diversa dalla immaginata, vi si inquadrano assai meglio.
Se la storia della Chiesa fosse davvero maestra, quanta maggiore cautela e quanta minore sicurezza nelle polemiche.
« Di qui non si passa ». Quando non si tratta di principi, è una parola da usarsi parcamente. Sono molte le strade del bene, e quelle da scoprirsi sono più belle se non più numerose di quelle che conosciamo.
I principi sono cardini del pensiero e della vita, e vanno affermati e vissuti e anche difesi. Ma nel difenderli, non bisogna mai supponi dove non sono riconosciuti. Gran parte degli uomini moderni sono senza principi, ed è una pericolosa illusione la nostra di difendere in altri un bene che non hanno mentre urge insegnare loro a ritrovarlo.
Diamo anche l’impressione di illiberali, perché cerchiamo di imporre ciò che, se è un bene per noi, non lo è per gli altri. Per tanta gente, che è costretta a vivere più da bestia che da uomo, non è facile accostarsi a una visione cristiana della vita.
E, sempre a proposito di principi, è almeno strano che certe difese a oltranza vengano fatte principalmente nei confronti dei poveri, i quali posti nel disumano dilemma di scegliere tra un principio morale e una tremenda necessità materiale, all’infuori di qualche caso di grazia, sono costretti ad arrendersi alla necessità.
Questo non è pessimismo, ma realtà di ogni giorno.
«Non dovrebbe essere così». D’accordo: ma la colpa non è solo dell’uomo, che è fatto com’è fatto, e cioè anche di corpo, ma pure nostra, che, dimenticandoci dell’uomo e della sua natura, gli offriamo senza umanità il bene spirituale.
«I principî! Che volete m’importino i vostri principî, se qui muoio di fame?».
Il Prodigo torna dal Padre perché si ricorda che nella «casa»‚ anche i servi «mangiano».
Questo è Vangelo, non materialismo.
Nei rapporti col comunismo, conviene tenere sempre presente la passione della giustizia che soffre negli umili, più che i postulati filosofici dei suoi intellettuali e le traduzioni economico-sociali che essi ne fanno, per vedere come essa s’accordi con la nostra sete di giustizia (non è la stessa sete?), e fin dove possiamo accompagnarci nel realizzarla, e a quali condizioni, ed entro quali limiti.
E dimostrare con i fatti che, pur credendo che solo «di là» essa avrà la sua piena soddisfazione, non lasciamo nulla di intentato per raggiungere anche il suo massimo di compimento terreno.
La nostra fede soprannaturale non diminuisce ma centuplica la nostra sete e il nostro sforzo verso la giustizia terrena.
Come noi vogliamo il diritto di far riserve e discutere la loro dottrina e la loro prassi politica, così dobbiamo loro riconoscere un eguale diritto nei nostri confronti, anche sul nostro passato non sempre molto edificante, sulla mentalità reazionaria di molti di noi e sulla nostra accidia sociale.
Anche oggi è più facile scoprire un bel volume di sociologia cristiana che imbattersi in un gruppo cristiano che intenda applicarla sul serio.
Non è la prima volta che nei parlamenti uomini di estrema sinistra ci rimproverano di non fare quello che i Pontefici vanno insegnando da anni nei loro messaggi sociali.
Nelle accuse c’è sempre un monito, se non proprio un po’ di verità: e trovo strano che proprio chi insegna di accogliere in buona parte le avversità si rivolti con sdegno amaro.
Non crediamoci intoccabili perché siamo i discepoli di Cristo. Ci ha egli forse garantito un trattamento diverso?
C’è un gridare, un protestare, un minacciare che non conclude.
Come possiamo pretendere che i comunisti rispettino in noi « qualcosa » o « qualcuno » di là di noi che essi non vedono ancora e che forse noi stessi impediamo di scorgere?
Siamo tuttora malati di una superiorità che non esiste se non in teoria e che ci crea un discreto imbarazzo, perché l’onore non è senza ònere.
Rientriamo e siamo contenti nel diritto comune.
L’insofferenza di esso, il desiderio del privilegio, ci hanno sempre portato alla schiavitù.
Preferisco battermi in rasa campagna che essere internato con onori e pensione di sovrano decaduto.
Questo duro guadagnarsi il diritto di rappresentare il Vangelo è un impegno e una gloria. E la nostra vocazione.
Comunismo, per molti, è bolscevismo. Quindi Russia, e lo spavento che si ripetano da noi gli orrori che si dicono compiuti laggiù: fine della civiltà cristiana, la persona sommersa nella collettività organizzata scientificamente…
Tutto è possibile, anche il trapianto senza discernimento di un’esperienza storica avvenuta in condizioni assai diverse dalle nostre. Il fanatismo è ben lungi dal cedere davanti alle ragioni della ragione, che purtroppo si muove con ritardo e può anche poco.
Prima di spaventarci, un mestiere che facciamo da anni con nessun guadagno, guardiamo in faccia il pericolo.
E cominciamo dai fatti.
La rivoluzione bolscevica, pur facendo le dovute riserve sulle notizie della propaganda occidentale, non è certo una storia edificante.
Quale rivoluzione però, tra quelle che sogliono essere ricordate con soddisfazione e con vanto dai nostri borghesi, sono avvenimenti edificanti?
Gli orrori, nella lontananza, si sono alquanto smorzati, ma i contemporanei della rivoluzione francese, la più nota e la più decantata, ne parlavano come molta brava gente di oggi parla del bolscevismo.
E la reazione nazi-fascista fu forse meno disumana? Eppure, quante persone dabbene che inorridiscono della Russia approvano ed esaltano gli orrori fascisti considerati una necessità per la difesa dell’ordine: il loro ordine, si capisce.
Nessuna rivoluzione, all’infuori di quella cristiana che è amore merita l’onore degli altari:
sono tutte brutte e deprecabili e non vale la pena istituire confronti.
Poniamoci piuttosto la domanda: Perché accadono?
Perché il popolo è una belva, e se gli uomini superiori non lo disciplinano e non lo contengono con ogni mezzo…
Vi dirò che non il popolo, ma l’uomo è una belva, compreso l’uomo che voi dite superiore.
E la belva viene fuori perché proprio gli uomini che si credevano superiori e che si sono fatti la parte del leone rendono talmente impossibile la vita agli altri che questi per liberarsi sono costretti a diventare belve.
Ci sono uomini-belve che si servono dell’ordine e uomini-belve che si servono del disordine, e non so quale delle due categorie sia la più nefasta.
Conosco però la più responsabile. Cosa hanno fatto le «classi superiori»‚ così pronte a inorridire delle gesta bolsceviche, per togliere o diminuire le ingiustizie che preparano le rivolte sanguinose?
Sarebbe più onesto aver orrore di noi stessi, pensando che molte volte ciò che compiamo tranquillamente in nome e sotto la garanzia delle nostre leggi non è meno infame delle più infami gesta rivoluzionarie.
La Russia fa paura. Ma chi la conosce veramente?
Furono scritti libri su libri e ne sappiamo meno di prima.
Sappiamo – almeno dovremmo saperlo – da quale spaventosa e secolare servitù è venuta faticosamente e dolorosamente sciogliendosi.
La liberazione non poteva essere un’impresa di ordinaria amministrazione; molto più che al popolo russo sono mancati gli aiuti delle forze spirituali e religiose che avevano fatto blocco con gli oppressori.
Per chi può ragionare, l’ateismo è un assurdo, ma in terra di Russia, la terra più religiosa del mondo, si sono avverate tali disgraziatissime situazioni che l’hanno fatto quasi logico.
Quando dovessimo soffrire come hanno sofferto i russi e ci accorgessimo che la religione si è messa in gara ad opprimere il popolo, faremmo fatica anche noi a separare la causa di Dio da quella di coloro che si servono di Dio per affrettare il nostro strangolamento.
Non conosciamo la Russia, è vero; e certe notizie venute di laggiù sono paurose. Ma c’è anche il fatto della guerra e come l’hanno combattuta i russi. Se il bolscevismo non avesse qualche cosa di buono, se, in confronto del passato non rappresentasse un guadagno, milioni e milioni di russi non avrebbe marciato, né si sarebbero lasciati uccidere come invece hanno fatto per quattro anni riempiendo il mondo di stupore e di ammirazione.
Il comunismo russo non è merce d’esportazione, e noi crediamo che il comunismo occidentale stia per darsi una sua fisionomia e un suo costume, molto più che il bolscevismo stesso ha camminato e cammina nella stessa direzione.
Tale lavoro, però, sarà spedito e sicuro se i cristiani, superate le stupide paure, sapranno riconoscere onestamente gli errori che possono condannare un popolo all’ateismo e ricondurre alle fonti vive del Vangelo l’enorme sete di giustizia che ne fu violentemente distaccata.
Se noi vogliamo sinceramente la giustizia e i comunisti pure sinceramente la vogliono: se noi vogliamo il bene comune ed essi pure lo vogliono… siamo già uniti, anche se non siamo sempre d’accordo sui motivi di partenza e sulle strade che conducono alla giustizia e al bene comune.
Non è quindi questione di concorrenza, come insinuano i maligni cui tornano assai proficue certe divisioni.
Ora, si tratta di dare non di prelevare: e dà di più non chi ha di più ma chi ama di più.
E per amare noi abbiamo la misura di Cristo, il cui nome benedetto viene umiliato e bestemmiato quando nei problemi della giustizia sociale ci lasciamo vincere in carità.
Purtroppo, sul piano della « città »‚ siamo stati vinti più volte, e lo saremo ancora, se ci accontenteremo di essere cristiani solo quel poco che ci verrà concesso dagli interessi e dai pregiudizi dei nostri protettori borghesi: se avremo in una parola paura di fare la rivoluzione cristiana.
(1945)
Filed under: Primo Mazzolri | No Comments »












 Icona
Icona














![[Madonna and Child from Japanese Carmel]](http://www.udayton.edu/mary/gallery/images/japan2.gif)
![[Japanese Madonna]](http://www.udayton.edu/mary/gallery/images/japan1.gif) Japanese Madonna
Japanese Madonna![[Japanese Madonna]](http://www.udayton.edu/mary/gallery/images/japan3.gif) Japanese Madonna
Japanese Madonna















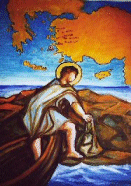




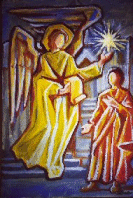



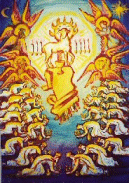
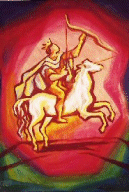



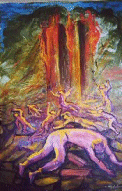

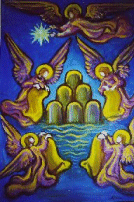
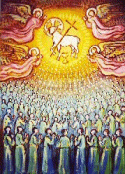
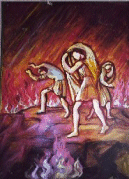



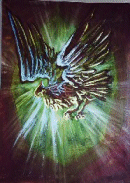

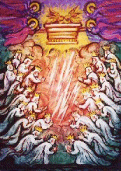

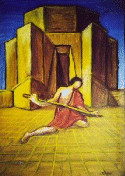
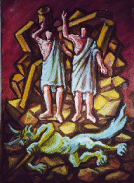



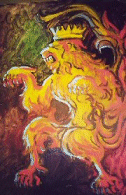









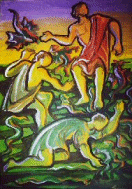
















 Di Ambrogio Chiari
Di Ambrogio Chiari Negli anni 1950-60 fra Mosé Bonardi, Superiore Generale dell’Ordine, animato da profondo spirito missionario, diede un impulso rilevante alle varie Province perché sviluppassero opere nei tre continenti più bisognosi: Africa, America del Sud ed Asia. Le Province si attivarono in tal senso e la Provincia Lombardo-Veneta si impegnò in Israele, con l’ospedale di Nazareth, succedendo nella gestione alla Provincia Austriaca nel 1959, ed in Togo e Dahomey (ora Benin) in Africa.
Negli anni 1950-60 fra Mosé Bonardi, Superiore Generale dell’Ordine, animato da profondo spirito missionario, diede un impulso rilevante alle varie Province perché sviluppassero opere nei tre continenti più bisognosi: Africa, America del Sud ed Asia. Le Province si attivarono in tal senso e la Provincia Lombardo-Veneta si impegnò in Israele, con l’ospedale di Nazareth, succedendo nella gestione alla Provincia Austriaca nel 1959, ed in Togo e Dahomey (ora Benin) in Africa.

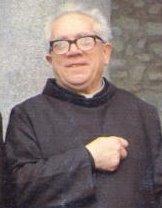 Se si dovesse scrivere una bella biografia di Michelini molte pagine dovrebbero essere dedicate alla sua attività africana. E chissà quante cose avrebbero potuto raccontare i religiosi fatebenefratelli fra Onorio Tosini, fra Tommaso Zamborlin, fra Aquilino Puppato, fra Clemente Tempella… ed altri ancora.
Se si dovesse scrivere una bella biografia di Michelini molte pagine dovrebbero essere dedicate alla sua attività africana. E chissà quante cose avrebbero potuto raccontare i religiosi fatebenefratelli fra Onorio Tosini, fra Tommaso Zamborlin, fra Aquilino Puppato, fra Clemente Tempella… ed altri ancora.