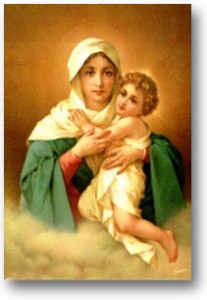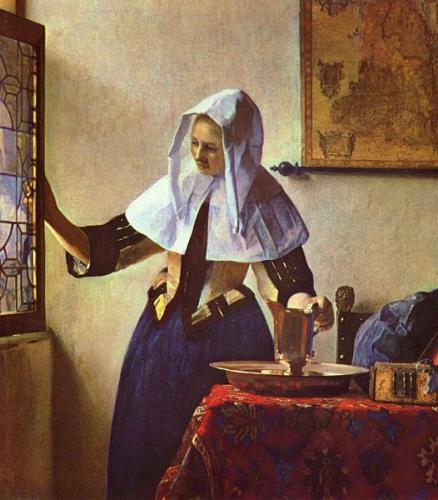CONVERSIONE INTELLETTUALE E PREGHIERA CONVENIENTE – C.M. Martini
Posted on Marzo 20th, 2009 di Angelo | Edit
CONVERSIONE INTELLETTUALE E PREGHIERA CONVENIENTE – C.M. Martini
di S. Em. Card. Carlo Maria Martini
Riportiamo due meditazioni ai sacerdoti della diocesi di Milano del Cardinal Martini – che ha compiuto da poco gli ottanta anni – tenute la prima a Triuggio il 18 ottobre 1991 e la seconda il 30 ottobre 1991 a Rozzano diocesi di Milano. Il cuore di questo grande Pastore continua a battere al ritmo del cuore di Cristo, e illumina con la sua spiritualità e la testimonianza della sua fede le coscienze di tanti cristiani e uomini di buona volontà in cerca della verità nella carità.I testi che seguono sono tratti da: Carlo Maria Martini, Briciole dalla Tavola della Parola, Edizioni Piemme, Casale Monferrato, 1996, pp.46- 54, e 55-61 Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la presenza on-line di questi testi sul nostro sito non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto.
04/03/2007
L’importanza della conversione intellettuale
Le diverse tappe dei vangeli
La festa liturgica di san Luca, che oggi celebriamo, mi ha suggerito di meditare su quella «conversione» che possiamo chiamare «intellettuale».
Essa infatti è bene espressa nell’insieme dell’opera lucana – vangelo e Atti degli apostoli -.
A modo di premessa, ci domandiamo: come si collocano i due libri di Luca rispetto agli altri tre vangeli?
Ricordo che nel 1980, all’inizio dunque del mio episcopato, avevo presentato, negli incontri di zona con i presbiteri, la figura globale del cristiano attraverso i quattro vangeli.
E dicevo che Marco è il vangelo del catecumeno, perché contiene l’essenziale per introdurre al battesimo; Matteo è il vangelo del catechista, perché introduce alla vita della comunità, della Chiesa; Luca è il vangelo del testimone, ín quanto prepara il cristiano all’evangelizzazione; Giovanni è il vangelo del presbitero, perché mostra la sintesi spirituale cui giunge un cristiano maturo che, dopo essere passato per le tre precedenti esperienze, diventa capace di assumere responsabilità di una comunità, come prete o come padre o madre di famiglia.
Di queste quattro tappe lungo le quali si snoda il cammino cristiano, esaminavo poi alcuni aspetti particolari chiedendomi, per esempio: Qual è lo stato di preghiera proprio di ciascuna tappa? Perché, evidentemente, non é lo stesso pregare come catecumeno o pregare come catechista o come evangelizzatore o come cristiano perfetto, illuminato. E quali sono i ministeri delle singole tappe? Quali le forme di intelligenza della fede, di cultura cristiana?
Oggi, supposta la quadruplice divisione dei vangeli secondo diversi livelli della vita cristiana, desidero aggiungere un’ulteriore riflessione sulla conversione.
La conversione è un evento molto importante, fondamentale per l’uomo. Cristiano è chi si converte dagli idoli a Cristo Gesù rivelatore del Padre e vive la, sua esistenza in modo nuovo, con quel modo nuovo di guardare la realtà tipico di colui che si riconosce peccatore, ma salvato, figlio di Dio, amato e perdonato.
Se tuttavia esaminiamo da vicino l’evento della conversione ci accorgiamo che comporta diversi volti, aspetti – non propriamente delle tappe – che storicamente si presentano talora anche separati.
Possiamo così parlare di conversione religiosa, di conversione morale, di conversione intellettuale e di conversione mistica. A titolo puramente esemplificativo (e nell’intento di illuminare meglio il tema della conversione intellettuale, che ci siamo proposti come centro della nostra riflessione) vorrei contemplare quattro figure di santi – Agostino, Ignazio di Loyoia, Newman e Teresa d’Avila – per cogliere, in ciascuno di essi, un volto della conversione cristiana. Tenendo tuttavia presente che questo volto, in loro, non è 1′unico. Ogni cristiano, infatti, dopo la prima conversione, quella battesimale, dovrebbe giungere gradualmente anche alle altre.
La conversione religiosa
Agostino ci mostra chiaramente il passaggio dalla non conoscenza del Dio della Bibbia alla conoscenza del Dio di Gesù Cristo.
Egli era molto confuso sull’idea di Dio e pensava addirittura a una duplice divinità, al principio del Bene e del Male. Dunque, prima ancora di una conversione morale e di una conversione mistica, Agostino ebbe una radicale conversione religiosa, grazie al contatto con Cicerone.
La racconta nelle Confessioni, quando parla della sua lettura dell’Ortensio: «Quel libro, devo ammetterlo, mutò il mio modo di sentire, mutò le preghiere stesse che rivolgevo a te, Signore, suscitò in me nuove aspirazioni e nuovi desideri, svilì d’un tratto ai miei occhi ogni vana speranza e mi fece bramare la sapienza immortale con incredibile ardore di cuore. Così cominciavo ad alzarmi per tornare a te». Il ritorno, il cambiamento di direzione del cammino, è l’inizio della conversione religiosa. «Come ardevo, Dio mio, come ardevo di rivolare dalle cose terrene a te, pur ignorando cosa volessi fare di me» (1II, 4. 7-8).
Era ancora incerto sul futuro, viveva ancora un’esistenza disordinata, però aveva intuito che in ogni caso Dio è tutto, è al di sopra di tutto, che Dio ha il primato.
E se ci domandiamo dove questo è espresso nelle tappe della predicazione evangelica e dei vangeli scritti, rispondiamo che si trova indubbiamente nel libro di Marco: esso proclama la «Buona notizia di Gesù Cristo, figlio di Dio» (1, 1) e chiama l’uomo a una scelta irrevocabile del Padre di Gesù Cristo, di questo Dio di Gesù morto sulla croce.
Il vangelo di Marco rappresenta il livello della conversione religiosa cristiana.
La conversione morale
Ignazio di Loyola ci permette di vedere un secondo volto della conversione. Credeva in Dio, era stato educato alla fede cristiana, si dedicava anche a qualche pratica religiosa, ma gli piacevano le vanità del mondo e la sua vita era piuttosto disordinata.
Trovandosi infermo a seguito di una ferita alla gamba, si mise a leggere una «Vita» di Cristo e alcune biografie di santi, che lo posero a confronto con se stesso. Riflettendo seriamente sul suo passato, comprese che pur riconoscendo già il primato di Dio, per essere degno dell’amore di Gesù, morto per salvarci, doveva cambiare modo di comportarsi. Da quel momento incomincia un cammino che lo porterà ad essere un vero uomo di Chiesa, profondamente obbediente alla realtà e all’istituzione ecclesiastica.
La sua è una conversione morale anche negli aspetti sociali, perché sfocia nel servizio alla comunità ecclesiale.
A tale aspetto della conversione richiama il vangelo di Matteo rivolto in particolare a quei fedeli che, avendo già accettato Cristo come la pienezza della legge e il predetto dai profeti, devono convertirsi alla Chiesa quale corpo di Cristo, devono accoglierla nella sua disciplina, nelle sue regole, nella sua struttura dogmatica.
La conversione intellettuale
E vengo a quel livello di conversione intellettuale su cui vorrei più precisamente concentrare la vostra attenzione, una conversione sottile e difficile da definire. La leggiamo nella figura del cardinale Newman.
Egli credeva profondamente in Dio e in Gesù, era moralmente molto retto, di grande austerità e santità
di vita. Intellettualmente, però, era molto confuso. Non sapeva quale Chiesa rappresenta veramente la Chiesa istituita da Gesù. Ed è interessante vedere nella sua autobiografia, la fatica mentale che ha dovuto compiere. Non dunque una fatica morale, e nemmeno religiosa, ma proprio la fatica di cogliere tra i diversi ragionamentí, le diverse argomentazioni, le molteplici teologie e filosofie, quella giusta.
A un certo punto del suo cammino, riflettendo attentamente sulle eresie del IV secolo, su come la Chiesa aveva superato 1′aríanesímo e il donatismo, intuì il principio di unità e la centralità di Roma. In proposito, Newman parla di «illuminazione» che cambiò la sua vita.
Si tratta di una conversione intellettuale; tocca, infatti, l’intelligenza che, dopo aver vagato attraverso opinioni e punti di vista confusi, diversi, contraddittori, finalmente trova un principio per il quale riesce a decidersi e a operare, non sotto l’influenza dell’ambiente o del parere degli altri, bensì per una illuminazione chiara e profonda.
Mi preme sottolineare che la conversione intellettuale è parte del cammino cristiano, pur se sono poche le persone che vi arrivano perché è certamente più comodo, più facile accontentarsi di ciò che si dice, di ciò che si legge, di come la pensano i più, dell’influenza dell’ambiente anche buono.
Tuttavia il cristiano maturo ha assoluto bisogno di acquisire convinzioni personali, interiori per essere un evangelizzatore serio in un mondo pluralistico e segnato da bufere di opinioni contrastanti.
In altre parole, la conversione intellettuale è propria, di chi ha imparato a ragionare con la sua testa, a cogliere la ragionevolezza della fede grazie a un cammino, forse faticoso, che lo rende capace di illuminare altri.
L’opera di Luca – vangelo e Atti – rappresenta quello stadio dell’itinerario cristiano in cui una persona, dopo la decisione religiosa di essere tutta del Dio di Gesù Cristo, dopo quella morale di vivere un’esístenza secondo la disciplina e gli insegnamenti della Chiesa, vuole a ogni costo cogliere il cammino cristiano nel mondo, nell’insieme delle filosofie e delle teologie tra loro diverse, con una chiarezza che deriva appunto dall’aver imparato a orientarsi in mezzo a un contesto difficile.
Luca insegna a orientarsi nel mondo pagano, a paragonare le tradizioni religiose pagane con quelle ebraiche, a mantenere la fedeltà al Dio di Israele, al Dio creatore e, in Gesù, redentore, pur vivendo al di fuori del popolo ebraico. La comunità primitiva si trovava di fronte a gravi problemi intellettuali e teologici: per esempio, bisogna imporre le forme religiose ebraiche, anche disciplinari, ai pagani oppure occorre operare una nuova sintesi?
Gli Atti degli apostoli ci fanno capire che è possibile un’evangelizzazione planetaria, che non è necessario riprodurre semplicemente il modello israelitico di pensiero e di pratica religiosa. Il grande merito di Luca consiste nell’aver affrontato in modo diretto ed esplicito il problema della cultura religiosa, della conversione intellettuale, quindi anche dell’evangelizzazione delle culture.
E la sua opera deve esserci particolarmente cara oggi, dal momento che viviamo in un universo culturale scomposto e confuso. Anche al tempo di Luca erano venute meno le ideologie e si assisteva a una mescolanza di vecchie e di nuove filosofie, di riti che venivano dall’oriente, di religioni misteriche; la gente era perplessa inquieta, aveva bisogno di orientamento, di certezze,di imparare a cogliere l’unità del disegno divino.
Ispirato da Dio, Luca ci ha offerto un modello di ,comportamento missionario al quale riferirci ancora oggi. Giovanni Paolo II lo riprende nell’enciclica Redemptoris missio, dove presta attenzione alle diverse religioni, al1e varie culture, al dialogo interculturale, ma con quella libertà, chiarezza e serenità che sono proprie di Luca.
Vorrei inoltre osservare che la stessa grande teologia di Paolo è uno sviluppo delle intuizioni di Luca. L’Apostolo costruisce una teologia che non si limita a rinnegare gli errori; essa tiene conto dei concetti buoni del rabbinismo sulla giustizia di Dio e delle riflessioni dello gnosticismo sull’unicità del cosmo. Per questo è molto importante leggere il vangelo di Luca e gli Atti degli apostoli nell’approfondimento teologico di Paolo, in particolare nelle Lettere ai Romani, ai Corinzi, ai Galati, agli Efesini, ai Colossesi.
Il Signore ha dunque provveduto alle colonne della sua Chiesa, a dirigere il consiglio e la scienza di questi uomini per insegnarci a meditare sui misteri di Dio, per permetterci di viaggiare tra genti straniere investigando il bene e il male, senza lasciarci contaminare, indagando la sapienza di tutti gli uomini e dedicandoci allo studio delle profezie (cf. Siracide 39).
Luca è riuscito a operare una sintesi tra visione giudaica del mondo, a partire da Abramo e dalle profezie, e una visione cosmica che poteva anche essere compresa dai pagani, partendo dal Dio creatore e dal primo uomo, considerando quindi tutta la successione dell’umanità chiamata a un unico disegno.
Lasciamoci perciò scuotere dal messaggio lucano verso una conversione intellettuale, nel desiderio di utilizzare la nostra intelligenza per valutare i fenomeni e gli eventi che si verificano intorno a noi, per non esserne emarginati o intimoriti.
Quello che propongo nella lettera pastorale Il lembo del mantello è proprio un aspetto della conversione intellettuale. Non chiedo di non guardare la televisione, bensì di imparare a giudicare, a criticare, a non essere succubi. Non guardarla sarebbe forse una buona conversione morale, ma non ci metterebbe a raffronto con molte delle opinioni del nostro tempo. La mia è davvero la richiesta di un salto di qualità nella capacità di autocritica, di critica dei mass media, nella capacità di non lasciarci ipnotizzare da essi. Eliminarli del tutto equivarrebbe a non parlare con i nostri contemporanei.
So bene, ripeto, che il passaggio alla conversione intellettuale richiede sforzo, volontà, pazienza, tempo, ma vi invito a farlo. Rimango sempre perplesso quando incontrando qualche comunità religiosa, anche contemplativa, mi accorgo che pur conducendo una vita pia, devota, santa, sacrificata, questi uomini o queste donne non hanno l’intelligenza spirituale della situazione della Chiesa. I nostri Padri, come Agostino e Ambrogio, non si sono distinti solo per la pietà o per la moralità; essi avevano acquistato quell’intelligenza che può giudicare da sé ciò che è bene e ciò che è male, che può rendere ragione delle proprie opzioni di fede.
Di questa maturità cristiana, che nasce dalla conversione intellettuale, noi abbiamo bisogno oggi per evangelizzare un’Europa così sofisticata e attraversata dalle più strane correnti di pensiero.
La conversione mistica
Il vangelo di Giovanni delinea il quarto volto della conversione cristiana, quella mistica che è bene esemplificata in Teresa d’Avila.
Teresa credeva in Dio, viveva una vita buona, e però lei stessa scrive che il monastero non l’aveva aiutata a compiere veramente un salto di qualità.
Dopo più di vent’anni di «mediocrità» ella entra, per grazia, in quello stato di semplificazione nel quale contempla il Signore presente in lei, in ogni membro del suo corpo mistico, in ogni persona e in ogni situazione, e contempla tutta la realtà in lui.
La conversione mistica è infatti quella condizione che ci permette di cogliere immediatamente la presenza di Dio ovunque. E lo stadio contemplativo del IV vangelo, il più consono per chi ha responsabilità presbíterali. Perché il presbítero è l’uomo della sintesi, l’uomo che sa vedere sempre lo Spirito santo in azione nella storia, e tutta la storia in Dio. Non è soltanto 1′evangelizzatore che proclama la Parola, ma anche il responsabile e, come tale, deve cogliere l’unità nei frammenti, l’unità nelle disparate attività, attraverso la preghiera continua e il senso dell’onnipresenza divina.
Conclusione
Gli evangelisti ci presentano un ideale di cammino cristiano da cui siamo certamente lontani, e tuttavia cí conforta sapere che Dio ci chiama a percorrerlo. Luca, in particolare, ci stimola a raggiungere una tappa estremamente importante per il nostro ministero.
Per il momento di silenzio, vi suggerisco di domandarvi se provate gratitudine per il dono degli scritti di Luca. Pensiamo come saremmo poveri se non li avessimo, se mancassero alla nostra vita i racconti dell’annunciazione, della natività di Gesù a Betlemme! Luca arricchisce grandemente la nostra sensibilità spirituale.
Come cerchiamo di trarre profitto dal suo vangelo e dagli Atti, per la nostra formazione a essere evangelizzatori? Come ci sforziamo di arrivare alla conversione intellettuale, che ci introduce nella comprensione del mondo e della storia? Ci lasciamo aiutare anche dalle iniziative che portano avanti il discorso di attenzione al significato dell’ambiente culturale circostante, che Luca ha avuto così vivo, senza perdere nemmeno una virgola della forza straordinaria della buona notizia di Gesù?
La natura misteriosa della preghiera
Introduzione
Sono stato molto colpito dalla prima lettura della messa feriale di oggi, mercoledì della trentesima settimana «per annum», in particolare dove si dice: «Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili; e colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri dello Spirito, perché egli intercede per i credenti secondo i disegni di Dio» (Romani 8, 26-27).
È un brano che mi ha sempre affascinato, incuriosito anche inquietato, perché non facile da spiegare, in quanto si riferisce alla natura misteriosa della nostra preghiera. Possiamo farci aiutare nella nostra riflessione dalla spiegazione che Agostino dà delle parole di san Paolo.
Nella Lettera a Proba che viene proposta nell’Ufficio di Lettura delle settimane venticinquesima e ventiseiesima del tempo «per anno» – il Vescovo di Ippona risponde alla domanda: Che cosa vuol dire pregare?
A proposito dei vv. 26-27 della Lettera ai Romani pone l’obiezione fondamentale: Che cosa significa che lo Spirito intercede per i credenti? E risponde: «Non dobbiamo intendere questo nel senso che lo Spirito santo di Dio, il quale nella Trinità è Dio immortale e un solo Dio con il Padre e con il Figlio, interceda per i santi, come uno che non sia quello che è, cioè Dio»1.
Dunque, se san Paolo sembra non avere difficoltà ad affermare che lo Spirito santo, cioè Dio, prega Dio, noi però teologicamente l’abbiamo.
Possiamo capire che il Figlio, in quanto incarnato in Gesù, prega il Padre; ma lo Spirito come fa a pregare il Padre?
Dietro a questo problema dogmatico, affrontato da Agostino, c’è poi tutto il problema della preghiera conscia e inconscia, della preghiera di cui ci accorgiamo o meno e quindi il brano della Lettera ai Romani costituisce una porta molto interessante per costringerci a entrare in questo mondo immenso.
Vorrei cercare di socchiudere almeno un poco quella porta incominciando col porre due premesse, quindi riprendendo l’espressione: lo Spirito intercede, prega, geme per noi.
Le due definizioni della preghiera
In una prima premessa richiamo le due definizioni tradizionalí della preghiera, che non sembrano andare tanto d’accordo.
- La preghiera è elevatio mentis in Deum, un elevare la mente a Dio. Il riferimento è anzitutto alla preghiera di lode, di ringraziamento, di esaltazione, quella che troviamo bene espressa nel cantico di Maria: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio salvatore». O, ancora, nella recita del Padre nostro, quando diciamo: «che sei nei cieli», parole che indicano l’innalzamento degli occhi, la dimensione verticale dell’orazione, che sale dal basso verso l’alto.
- L’altra definizione è petitio decentium a Deo, che probabilmente è complementare alla precedente. La richiesta a Dio di ciò che conviene è una preghiera che si esprime soprattutto nella domanda, nella supplica, nell’implorazione, nella petizione. Se circa una metà dei salmi sono di lode e di esaltazione, l’altra metà sono di petizione, di supplica, di richiesta di perdono. Così pure il Padre nostro, se nella prima parte è elevatio mentis in Deum, nella seconda parte è petitio, richiesta di cose convenienti (il pane, la liberazione dalla tentazione, il perdono). Anche l’Ave Maria incomincia con l’elevazione della mente a Maria e a Gesù e poi si fa richiesta di preghiera per noi peccatori.
Ci sono dunque due linee che si intersecano, quella orizzontale e quella verticale, e costituiscono nel loro insieme la preghiera cristiana. Può essere allora utile, parlando della preghiera, mettere a fuoco ora l’uno ora l’altro dei due elementi, che si alternano anche nella nostra esistenza: a volte siamo più portati a elevare la mente a Dio (nel «prefazio» della messa, per esempio), in altri momenti alla petitio decentium a Deo (come nelle orazioni della messa).
Come si realizza questo secondo elemento della preghiera, che è la richiesta di cose convenienti?
Scrive Agostino nella Lettera a Proba: «Il pregare consiste nel bussare alla porta di Dio e invocarlo con insistente e devoto ardore del cuore. Il dovere della preghiera si adempie meglio con i gemiti che con le parole, più con le lacrime che con i discorsi. Dio infatti “pone davanti al suo cospetto le nostre lacrime”(Salmo 55, 9), e il nostro gemito non rimane nascosto (cf. Salmo 37, 10) a lui che tutto ha creato per mezzo del suo Verbo, e non cerca le parole degli uominí»2.
Risuona la parola di Gesù: Quando pregate, non pensate di ottenere attraverso il vostro molto pregare, perché il Padre sa benissimo ciò di cui avete bisogno. Tuttavia Gesù stesso ci insegna a esprimere i nostri bísogni. Non tanto però – dice Agostino – con la moltiplicazione delle parole in quanto tale, bensì con una moltiplicazione che esprima il gemito del credente. Viene così introdotta la nozione di «gemito» che ritroviamo nella pagina di san Paolo.
Concludendo, la preghiera di richiesta deve partire dal cuore, non va fatta superficialmente, deve essere un gemito, un desiderio profondo. Gemere, infatti, significa anelare a qualcosa di cui si ha estremo bisogno; anche fisícamente il gemito è l’espressione di chi, mancando di aria, cerca di aspirarla.
Che cos’è conveniente chiedere nella preghiera
Una seconda premessa, limitandoci alla preghiera di petizione: che dobbiamo chiedere? La formula patristica dice: decentium, cose conveníenti. E comincia il problema: che cosa ci conviene? Perché Dio non ci dona ciò che non conviene, pur se lo domandiamo. Non a caso Matteo conclude la riflessione sulla preghiera con queste parole: «quanto più il Padre vostro celeste darà cose buone a coloro che gliele chiedono», cose che convengono (Matteo 7, 11).
Paolo insegna che noi non sappiamo che cosa ci conviene («Nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare») e quindi dobbiamo istruirci sulle cose convenienti per poter pregare bene.
I Padri insistono soprattutto su una cosa conveniente, che esprimono con un’unica parola, ben indicata nella Lettera a Proba: «Quando preghiamo non dobbiamo mai perderci in tante considerazioni, cercando di sapere che cosa dobbiamo chiedere e temendo di non riuscire a pregare come si conviene. Perché non díciamo piuttosto col salmista: “Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore e ammirare il suo santuario” (Salmo 26, 4)?».
E Agostino specifica: si tratta della «vita beata»3. Tale formula sintetica ha il vantaggio di una lunga tradizione filosofica: parte da Aristotele, è ripresa dallo stoicismo, riappare in Cicerone, è usata da Ambrogio.
La sola cosa che dobbiamo chiedere, l’unico oggetto fondamentale della richiesta è la vita beata, la vita felice. Continua la Lettera a Proba: «Per conseguire questa vita beata, la stessa vera Vita in persona ci ha insegnato a pregare, non con molte parole, come se fossimo tanto più facilmente esauditi, quanto più siamo prolissi (…). Potrebbe sembrare strano che Dio ci comandi di fargli delle richieste quando egli conosce, prima ancora che glielo domandiamo, quello che ci è necessario. Dobbiamo però riflettere che a lui non importa tanto la manifestazione del nostro desiderio, cosa che egli conosce molto bene, ma piuttosto che questo desiderio si ravvivi in noi mediante la domanda perché possiamo ottenere ciò che egli è già disposto a concederci (… ). Il dono è davvero grande, tanto che né occhio mai vide, perché non è colore; né orecchio mai udì, perché non è suono; né mai è entrato in cuore d’uomo, perché è là che il cuore dell’uomo deve entrare (…). E perciò che altro vogliono dire le parole dell’Apostolo: “Pregate incessantemente” (1 Tessalonicesi 5, 17) se non questo: desiderate, senza stancarvi, da colui che solo può concederla, quella vita beata che niente varrebbe se non fosse eterna?»4.
La domanda che Dio esaudisce sempre, la domanda che è oggetto di gemito è la pienezza della vita, la vita eterna.
Ogni richiesta che non è orientata a questa non è conveniente e non può né deve essere oggetto di preghiera.
E quando non sappiamo se ciò che chiediamo è o non è ordinato alla vita beata, allora lo è sotto condizione, lo è se e in quanto ci è utile per tale vita.
Mi sembra molto importante capire qual è la cosa fondamentale nella quale si riassume ogni nostro desiderio e ogni nostra richiesta. Noi, uomini e donne, noi persone umane storiche, siamo ciò che desideriamo; il nostro desiderio è il farsi della personalità. Se dunque il nostro desiderio culmina in questa pienezza di vita, diventiamo davvero in Cristo questa pienezza di vita.
Ma se i nostri desideri sono limitati, inferiori, noi stessi finiamo con l’essere persone limitate, blocchiamo il nostro sviluppo verso la pienezza della vita.
Forse a noi dice poco il termine «vita beata» che, invece, era tanto significativo per gli antichi. Lo stesso Nuovo Testamento usa un’altra espressione: «Regno di Dio»; le richieste «venga il tuo Regno», «sia fatta la tua volontà» sottolineano dunque che il desiderio e le invocazioni della seconda parte del Padre nostro sono subordinate al Regno, sono mezzi, condizioni per il suo avvento. E ancora, il Nuovo Testamento parla di «Spirito santo».
Gesù, conclude l’istruzione sulla preghiera nel vangelo secondo Luca, dopo aver esortato a cercare, a bussare, a chiedere, con queste parole: «Se dunque voi che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito santo» (Matteo dice: «cose buone») «a coloro che glielo chiedono» (Luca 11, 13). L’oggetto della domanda è lo Spirito santo, che significa la vita con Cristo, l’essere con lui, la pienezza della vita beata che consiste nell’essere incorporati per sempre a Gesù nella Chiesa.
Le diverse espressioni (vita beata, Regno, Spirito santo) in realtà si completano, si integrano, si sovrappongono come l’oggetto fondamentale della preghiera di domanda, e quindi come l’oggetto del gemito, dell’attesa.
Proclamando, per esempio: «nell’attesa della tua venuta», esprimiamo il nostro desiderio di fondo, cioè che la pienezza del Regno si realizzi, che lo Spirito santo venga e purifichi ogni realtà, che l’umanità si ritrovi presto nella vita beata, nella perfetta pace e nella perfetta giustizia. Sant’Ambrogio usa anche un altro termine: il bene sommo, summum bonum, che ha forse il vantaggio di dire insieme l’essere di Dio e il suo comunicarsi a noi nello Spirito, nel Regno, in Gesù, nella Chiesa, nella Grazia, nella pienezza della redenzione.
Questo dunque è ciò che dobbiamo chiedere, con assoluta certezza di ottenerlo, alla luce della Sacra Scríttura e dell’insegnamento dei Padri.
1 Lettera a Proba 130, 14, 27 – 15, 28; CSEL 44, 71-73.
2 Ibid., 130, 9, 18 – 10, 20: CSEI. 44, GO-63
3 130, 8, 15.17 – 9, 18: CSEL 44, 56-57.59-60
Filed under: ADESSO - Inserzioni iscritti, CARLO MARIA MARTINI Arcivescovo di Milano | No Comments »




 Di Elena Bosetti
Di Elena Bosetti